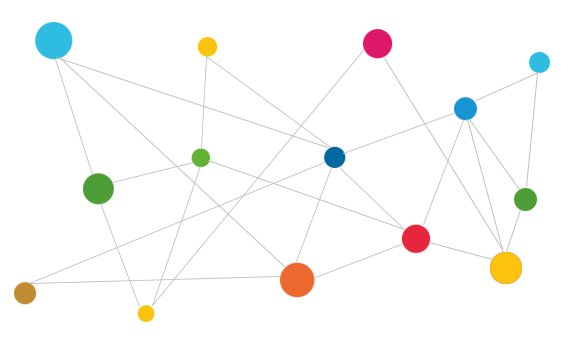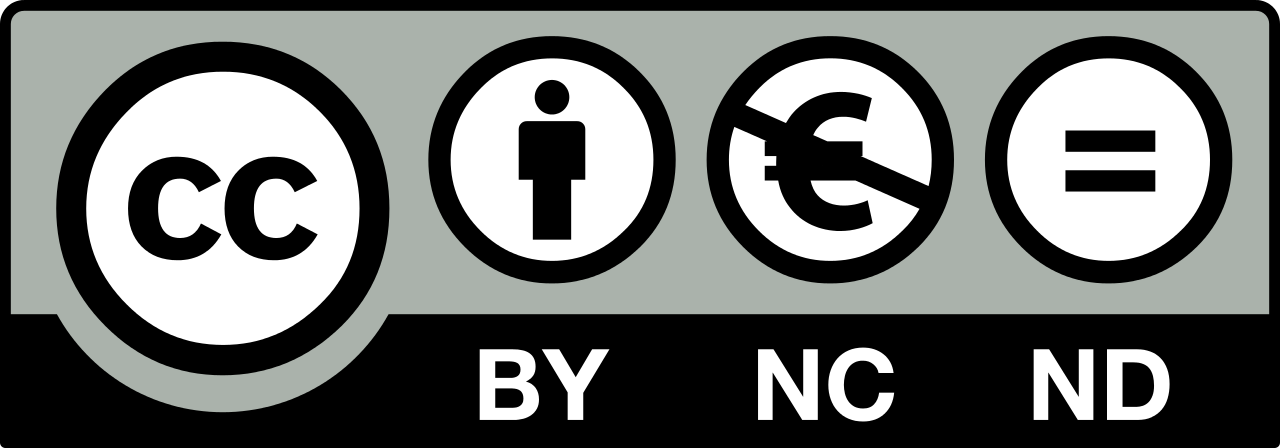Editoriali
Nessuno può salvarsi se non salviamo i più deboli, a cominciare dall’Africa
Giornate di grandi incontri internazionali e di appelli: il debito dei Paesi più fragili, l’esigenza di vaccini per tutti e i fondi necessari per combattere la crisi climatica pongono all’Occidente problemi ormai ineludibili.
di Donato Speroni
Mettiamo insieme un po’ di dati recenti.
Nel 2050, l’Africa raddoppierà la popolazione attuale, da 1, 2 a 2,5 miliardi di persone, circa un quarto dell’intera umanità. Se anche i tassi di fecondità scendessero, la quantità di giovani donne in età fertile presenti nel Continente nero è tale da rendere questa proiezione pressoché immodificabile.
L’aspirazione a emigrare è molto forte tra i giovani in Africa e in Medio Oriente. Un recente articolo pubblicato da Moisés Naim, scrittore considerato dalla rivista inglese Prospect tra i più autorevoli pensatori del mondo, ci fornisce dati molto significativi per quanto riguarda i giovani arabi, ma non c’è ragione di pensare che la situazione sia diversa nell’Africa subsahariana, dove le condizioni di vita sono anche peggiori.
Un indicatore della frustrazione dei giovani arabi è che circa la metà di loro ha pensato o pensa di emigrare all'estero. In alcuni Paesi del mondo arabo, questi aspiranti emigranti sono una maggioranza schiacciante: vorrebbe andarsene via il 77% in Libano, il 69% in Libia e il 56% in Giordania. Questi dati sono ricavati da un sondaggio realizzato dalla società di comunicazione Asda'a-Bcw. (...) I ragazzi intervistati vogliono governi meno corrotti e più efficienti, che siano capaci di creare occupazione e migliorare la qualità dell'istruzione. L'87% di loro è preoccupato dalla disoccupazione e più della metà non pensa che il governo sia in grado di offrire soluzioni a questo problema.
In realtà non tutti questi giovani vogliono venire da noi. Nello stesso articolo, pubblicato da Repubblica, Naim annota
un'altra rivelazione interessante: l'attrazione che esercitano gli Emirati arabi uniti. I1 34% è convinto che gli Emirati abbiano accresciuto la loro influenza nella regione, secondi solo all'Arabia saudita (il 39%). Gli Emirati risultano, per il nono anno consecutivo, il Paese dove i giovani arabi desiderano vivere: il 46% li indica come destinazione preferita per emigrare, davanti agli Stati Uniti al 33%. È il dato che fa più effetto, perché sembra indicare che il desiderio principale di questi giovani non è vivere in Occidente: quello che vogliono è vivere in un Paese che funziona.
Del resto “per il 40% di loro la religione è l’elemento che concorre maggiormente a determinare la propria identità” e non c’è quindi da stupirsi che molti desiderino continuare a vivere in un Paese musulmano.
Anche così, è facile prevedere una forte e crescente pressione demografica dall’Africa e dal Medio Oriente sull’Europa. Secondo le ultime proiezioni di Eurostat, la popolazione complessiva dei 27 Paesi europei scenderà dai 447 milioni del 2019 a 441 milioni nel 2050, anche tenendo conto delle dimensioni attuali dei flussi migratori, con un invecchiamento della popolazione mediana di quasi cinque anni, fino a 48 anni. Oggi l’età mediana in Europa è di 43 anni, in Africa di 19. L’Europa avrà bisogno di manodopera giovane e dovrà avere politiche di accoglienza lungimiranti. Ma è evidente che l’emigrazione non è la soluzione per la “bomba demografica africana”.
In realtà la situazione del Continente è molto più articolata di come comunemente viene dipinta. Circa un anno fa, l’Economist dedicò un suo special report al “secolo africano”, descrivendo la crescente importanza dell’Africa nella geopolitica dei prossimi decenni. Il quadro era a tinte molto contrastanti, a causa innanzitutto della diversa qualità dei governi locali, dimostrata da una serie di raffronti:
La prima lezione, molto semplicemente, è che bisogna avere uno Stato che funziona come dimostrano il Ruanda e Burundi, due Stati piccoli, senza accesso al mare, molto popolati, segnati dal genocidio delle minoranze Tutsi. Nel 1990 il Burundi era quasi due volte più ricco del Ruanda, ma da allora i redditi in Ruanda a parità di potere d’acquisto si sono triplicati mentre quelli del Burundi sono diminuiti. Una grande differenza è data dalla qualità dei governi. Anche se entrambi i paesi non possono definirsi democratici, il Ruanda ha un governo efficiente con poca corruzione, collocato all’ottavo posto in Africa nella classifica della qualità della governance della Mo Ibrahim Foundation. Il Burundi è al 43 esimo posto su 54 Stati.
Un altro esempio viene dallo Zimbabwe e dal Botswana. All’inizio degli anni ‘80 lo Zimbabwe era più ricco del Botswana. Poi Robert Mugabe ne ha distrutto l’economia stampando banconote senza limiti e rubando le fattorie per i suoi scagnozzi. Oggi il Botswana è sette volte più ricco dello Zimbabwe.
La qualità dei governi locali è certamente importante, ma il rebus africano non si risolve senza una intensa collaborazione internazionale. Anche perché il mondo ha un debito con l’Africa, non solo per i guasti dell’antico colonialismo, ma per torti inflitti più di recente a questo continente, a cominciare dal furto delle terre, ben descritto sulla Stampa da Domenico Quirico.
Sessanta anni dopo illusorie indipendenze, il colonialismo ha assunto aspetti nuovi più subdoli, reintegrando, con la consueta complicità di affaristi e “compradores” locali, antiche schiavitù. Ritorna, dietro l'anonimato dei Fondi speculativi e delle multinazionali dell'agrobusiness la figura coloniale per eccellenza, il Padrone. Che non sia più soltanto inglese o francese ma anche cinese o degli Emirati, nulla cambia. Spogliazione selvaggia: basta leggere le cifre: negli ultimi venti anni più di 35milioni di ettari di terre africane sono state cedute a capitali stranieri. È quello che chiamano “land grabbing”, l'ennesima piaga d'Africa, il nuovo nome del colonialismo dell'epoca della globalizzazione a cui la crisi alimentare del 2008 ha impresso un feroce impulso.
Che fare dunque? In questi giorni, nella “sessione di primavera” della Banca mondiale (Wb) e del Fondo monetario internazionale (Fmi) e nella riunione dei ministri delle finanze del G20 si è parlato molto della necessità di politiche globali a favore degli Stati e delle popolazioni più fragili, con una attenzione particolare rivolta verso l’Africa. Anche Papa Francesco, in una lettera a Fmi e Wb, ha invitato a riflettere su questo punto.
Mentre molti Paesi stanno consolidando i loro piani di ripresa, resta l’urgente necessità di un piano globale per creare nuove istituzioni o rigenerare quelle esistenti, soprattutto nel campo della governance globale, e per contribuire alla costruzione di una nuova rete di relazioni internazionali in grado di promuovere lo sviluppo umano integrale di tutte le genti. Questo significa necessariamente dare ai Paesi più poveri e meno sviluppati una quota effettiva di potere decisionale e facilitarne l’accesso ai mercati internazionali. Lo spirito della solidarietà globale richiede anche quanto meno una riduzione significativa nel peso dei debiti delle nazioni più povere, diventato ancora più pesante a seguito della pandemia. Rimuovere il peso del debito di tanti Paesi e di tante comunità è oggi un gesto profondamente umano che può aiutare la gente a svilupparsi, ad avere accesso ai vaccini, alla salute, all’educazione, ai posti di lavoro.
Oltre a questo appello, la Chiesa ha lanciato una campagna per la cancellazione del debito, come riferisce Avvenire, con una forte mobilitazione delle istituzioni ecclesiastiche del continente africano.
Anche il climate change dovrebbe farci sentire in colpa. “L’Africa è responsabile solo del 2% delle emissioni di gas serra, ma è il continente che dovrà subire le conseguenze più pesanti a seguito della crisi climatica”, dice Mafalda Duarte, responsabile del Climate Investment Funds creato dalla Banca Mondiale. Infatti le esigenze di intervento sui Paesi più fragili non si esauriscono nella cancellazione del debito, perché servono anche molti capitali, innanzitutto per combattere la crisi climatica. Nella riunione della Banca Mondiale, si è discusso anche dell’investment gap che rischia di far fallire le prossime trattative sul clima. Entro il 2030, secondo le stime dell’Unep, i Paesi più poveri dovranno spendere da 140 a 300 miliardi di dollari all’anno per affrontare misure di adattamento come le difese costiere, ma anche per decarbonizzare le loro economie. Anche questa è una realtà che ci riguarda molto da vicino, perché le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia ci dicono che l’aumento della domanda di energia nei prossimi anni proverrà soprattutto dai Paesi in via di sviluppo ed è quindi sui loro sistemi energetici che si condurrà la battaglia più importante contro la crisi climatica.
In parallelo con queste discussioni si svolge quella per la sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid: la richiesta avanzata da 80 Paesi in via di sviluppo è stata bloccata al Wto, ma è evidente che se non si troverà una soluzione che consenta una vaccinazione universale, non saremo mai veramente fuori da questa pandemia.
Il debito dei Pesi più poveri, i finanziamenti contro la crisi climatica, la liberalizzazione dei vaccini sono tre problemi che si possono ricondurre a un unico denominatore: la necessità di una visione globale per affrontare il futuro, una visione nella quale non esistiamo più “noi” contrapposti a “gli altri”.
Come disse un anno fa Papa Francesco, in una San Pietro già deserta:
Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo.