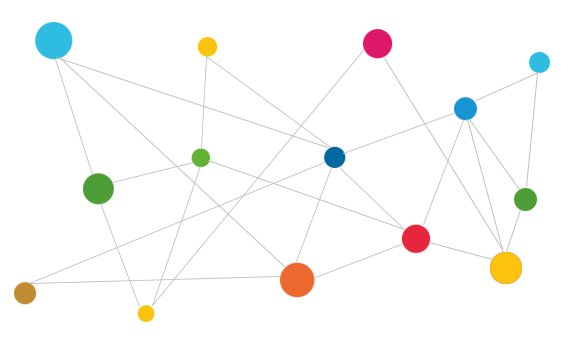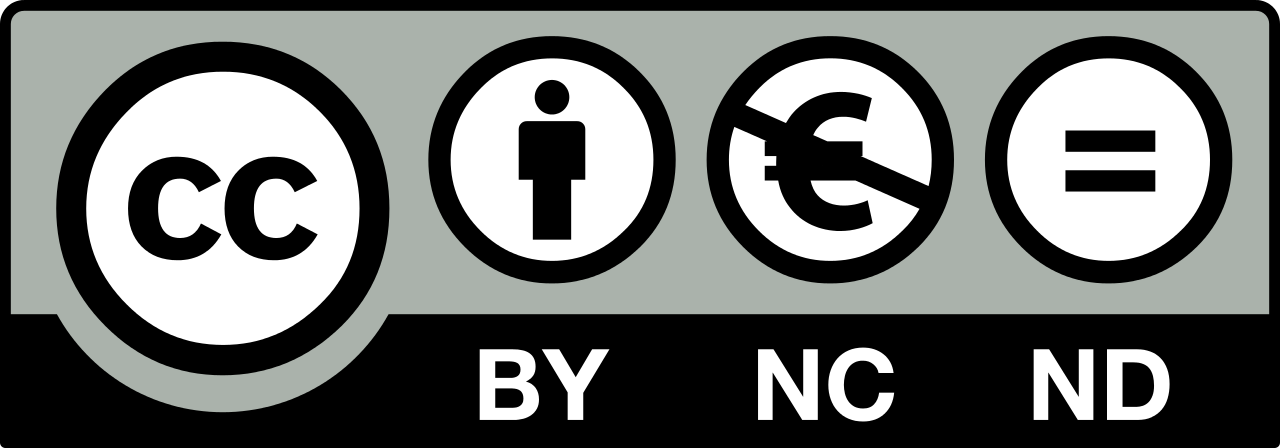Archivio editoriali
Il nostro destino è indissolubilmente legato a quello dei Paesi più poveri
Dalle migliaia di minori che le famiglie africane spingono a emigrare, ai confronti di Sharm el-sheikh sui finanziamenti climatici, il Sud del mondo cerca una prospettiva sostenibile. E noi non gliela stiamo dando.
di Donato Speroni
È accaduto ancora: tra i naufraghi sbarcati a Catania per insopprimibili ragioni umanitarie, erano numerosi i minori non accompagnati. E molti di loro provenivano dal Gambia. In quel Paese, dove capitai nel 1965, nel corso di un giro in Africa occidentale come giornalista free lance, lasciai un pezzo di cuore. Banjul, la capitale, che all’epoca si chiamava Bathurst, aveva 12mila abitanti ed era un borgo tranquillo sulle rive del fiume che dà il nome al Paese. Il turismo sulle sue spiagge dorate non era ancora esploso. Il mio arrivo fece notizia (!) e il ministro dell’Educazione veniva in albergo a giocare a scacchi con me. Conobbi l’uomo più ricco dello Stato, un libanese, che mi mostrò la sua bellissima Mercedes, per poi commentare “Sì, ma che me ne faccio, in un Paese con solo un chilometro di strada asfaltata?”. Viaggiai anche all’interno e andai a trovare il governatore di una provincia lontana, unico civil servant inglese rimasto, perché proprio in quelle settimane era in corso la transizione amministrativa dal controllo britannico all’indipendenza. Due soli bianchi nel raggio di molti chilometri: non fu un incontro emozionante come quello tra il dottor Livingstone e mister Stanley, ma fu stimolante. Di fronte all’immancabile tazza di tè ci scambiammo le nostre impressioni: entrambi credevamo nel futuro di quella nazione, non ricca ma nel complesso felice.
Come è possibile che da quella sottile striscia di terra lungo il fiume Gambia, che taglia in due il Senegal e raccoglie poco più di due milioni di abitanti, provenga ora il maggior numero di minori non accompagnati che tentano la fortuna per raggiungere l’Europa? Che cosa induce i giovani a fuggire? La domanda si può allargare: l’Africa che conobbi in quel viaggio, il mio primo nel Continente nero, aveva un suo equilibrio e all’indomani della decolonizzazione era piena di speranze. La violenza era molto circoscritta. Giravo per Lagos da solo anche al tramonto con una Rolleiflex al collo e visitai Kano affittando una bicicletta. Adesso per Lagos si viaggia con macchine blindate e a Kano, nel nord della Nigeria, è costante la minaccia jihadista.
Ci sono tante cause che spiegano il peggioramento della situazione africana. La prima è certamente l’eredità del colonialismo, con il suo carico di sfruttamento, i confini artificiali disegnati mettendo insieme popolazioni in conflitto, la mancata preparazione delle classi dirigenti, la corruzione continuamente proposta dalle multinazionali per assicurarsi vantaggi economici. Ma certo quello che è avvenuto nei 60 anni successivi alla decolonizzazione non può essere tutto attribuito ai vecchi padroni coloniali e ai loro nipoti. Nel caso del Gambia, l’elemento che ha determinato la crisi del Paese è stato la incapacità di sviluppare le zone interne. Mentre la costa si arricchiva grazie al turismo, più a est, lungo le rive del fiume dove si vive di pesca e di un’agricoltura di sussistenza, il 70% della popolazione è scesa al disotto dell’indice di povertà estrema. È una malattia che affligge buona parte dell’Africa: l’accentuarsi del divario tra zone rurali e zone urbane, oltre alla crescita della popolazione che un’agricoltura impoverita dai cambiamenti climatici non può più mantenere, fa sì che si rompano gli equilibri tradizionali e si gonfino le metropoli (e le migrazioni) a danno delle campagne.
Resta la domanda: come mai un Paese così piccolo è in testa nelle provenienze in Italia dei minori non accompagnati, un fenomeno segnalato già nel 2014 e che trova conferma negli arrivi più recenti? In realtà i ragazzi non provengono quasi mai dalle aree più disastrate. Per finanziare l’avventura di un viaggio in Europa, le famiglie devono essere disposte a spendere migliaia di dollari, per la traversata del Sahara, i taglieggiamenti degli aguzzini libici, il passaggio del Mediterraneo. In certi casi, sono proprio i ragazzi delle famiglie più benestanti a tentare l’avventura, come nel caso di Bakary,
il cui padre faceva parte della aristocrazia militare gambiana, della selezionatissima cerchia di coloro che si occupavano della sicurezza del Presidente Yahya Jammeh.
Quando nel 2016 Jammeh perse le elezioni e, nonostante il tentativo di opporsi, fu costretto a lasciare il potere da un intervento della Economic community of west african states (Ecowas), fu il padre stesso a spingere il ragazzo a partire, temendo di non potergli più garantire un futuro e sapendo che in Europa i minori non possono essere respinti. E alla fine, dopo innumerevoli peripezie, Bakary a 16 anni è arrivato in Italia.
La sua storia ci dice due cose. La prima è che non basta fornire aiuti ai Paesi più poveri: è necessario coinvolgerne le classi dirigenti in una prospettiva di graduale costruzione di un benessere accettabile e sicuro, per loro e per i loro figli. La seconda è che la vecchia distinzione tra “richiedenti asilo” e “migranti economici” ormai fa acqua da tutte le parti. Da un lato infatti il terzo comma dell’articolo 10 della Costituzione
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
è in realtà inapplicabile perché potrebbe valere per almeno metà della popolazione mondiale, se si presentasse ai nostri confini. Era un’affermazione di principio che poteva valere quando le migrazioni erano un fenomeno limitato, ma non è più sostenibile oggi, quando almeno un miliardo di persone, ci dice la Gallup, vorrebbe andarsene da dove vive. Solo in Tunisia, Paese non più democratico, sette milioni di persone su 12 vorrebbero emigrare. In teoria dovremmo accoglierli tutti.
Al tempo stesso, è sempre più difficile isolare e respingere la categoria dei “migranti economici”: anche quando provengono da Paesi non in guerra e con regimi democratici, i migranti possono avere alle spalle storie personali di persecuzione (tipico il caso degli omosessuali nei Paesi musulmani) o situazioni insostenibili a causa dell’inaridimento delle terre: per loro è impossibile ipotizzare un ritorno alle zone d’origine.
È difficile intravedere una soluzione globale, ma è certo che nessun Paese può affrontare da solo il problema di una nuova definizione dei diversi status dei migranti. E su questo tema complessivo, non solo su come ripartirsi chi arriva sui barconi, dovrebbe discutere l’Unione europea per darsi una strategia comune.
La collaborazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri in questi giorni è anche all’ordine del giorno nella Cop27 sul clima di Sharm el Sheikh, che sul sito Asvis seguiamo quotidianamente. Ci sono almeno due aspetti significativi. Il primo è il mancato finanziamento del Green climate fund, il fondo da 100 miliardi di dollari all’anno che i Paesi ricchi si erano impegnati a devolvere, a partire dal 2020, a favore della transizione ecologica dei Paesi in via di sviluppo, quelli dove maggiormente crescerà nei prossimi anni il fabbisogno di energia e che quindi rischiano di aumentare maggiormente le emissioni se soddisferanno questa crescita con combustibili fossili. Secondo una stima di Oxfam riportata dall’analisi “Finanziamenti per il clima” del Comitato tecnico scientifico della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, la cifra effettivamente fornita per il 2020 sta tra i 21 e i 24,5 miliardi di dollari, a fronte di dichiarazioni dei Pesi che sostengono di averne versati 68,3. Qui sta il cuore del problema della mitigazione del cambiamento climatico. L’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia, il World energy outlook 2022, avverte che continuando di questo passo l’incidenza dei combustibili fossili sulla produzione di energia scenderà soltanto dall’attuale 80 al 60% nel 2050, confermando un percorso di riscaldamento globale oltre i 2,5 gradi a fine secolo. Ben diversi sarebbero gli interventi necessari per arrivare davvero a emissioni zero nel 2050. L’obiettivo però comporterebbe un fortissimo impegno di decarbonizzazione nei Paesi in crescita, con ingenti finanziamenti da parte di quelli più ricchi, che sono ben lontani dal manifestare questa solidarietà.
L’altro tema finanziario all’ordine del giorno alla Cop 27 si chiama “Loss and damage” cioè la copertura dei costi che i Paesi più poveri devono sopportare a causa dei cambiamenti climatici e per gli investimenti necessari per adattarsi all’inevitabile: si pensi per esempio agli Stati insulari che rischiano di essere sommersi dall’aumento dei mari. A Sharm questo è uno dei temi più scottanti e ben difficilmente si raggiungerà un accordo.
Non c’è da stupirsi che, di fronte all’enormità dei problemi irrisolti, l’atteggiamento di molti Paesi del cosiddetto Sud del mondo nei confronti dell’Occidente sia segnato da una profonda diffidenza. Anche il rifiuto di associarsi alle sanzioni contro la Russia e alla condanna dell’invasione dell’Ucraina non è in molti casi un avallo alla politica di Mosca, ma un segnale nei nostri confronti. I Paesi più ricchi sono cresciuti inquinando l’atmosfera e scaricandone le conseguenze anche sul resto del mondo, ma ora chiedono a tutti comportamenti virtuosi e si rifiutano di pagare per i danni provocati. Difficile in questa situazione richiedere cooperazione e solidarietà.
In conclusione, mi sembra che l’Occidente (intendendo con questa espressione l’insieme dei Paesi ricchi, diciamo il G7), abbia di fronte a sé due strade: o farsi carico di una strategia di effettiva collaborazione che deve riguardare tutti gli aspetti del rapporto con i Paesi in via di sviluppo e cioè fattori climatici, ma anche gestione delle migrazioni e costruzione di un sistema economico che dia speranza ai giovani senza dover emigrare; oppure rinchiudersi in una sorta di fortezza che rifiuta di farsi carico dei problemi del resto del mondo. Ma così facendo non potremo contenere gli effetti climatici, abbattere l’inquinamento e il degrado della biosfera e neppure evitare le grandi ondate migratorie che quando le situazioni sociali sono troppo diverse diventano incontrollabili.
Immagine: mappa del Gambia, fonte Wikipedia.