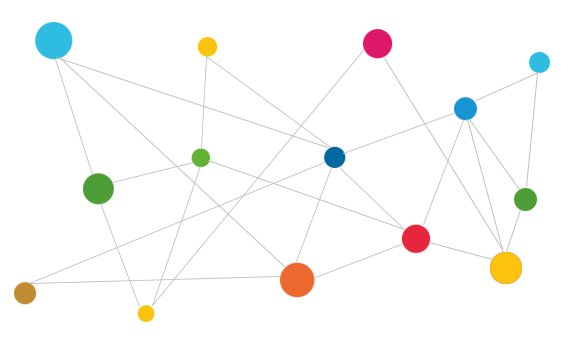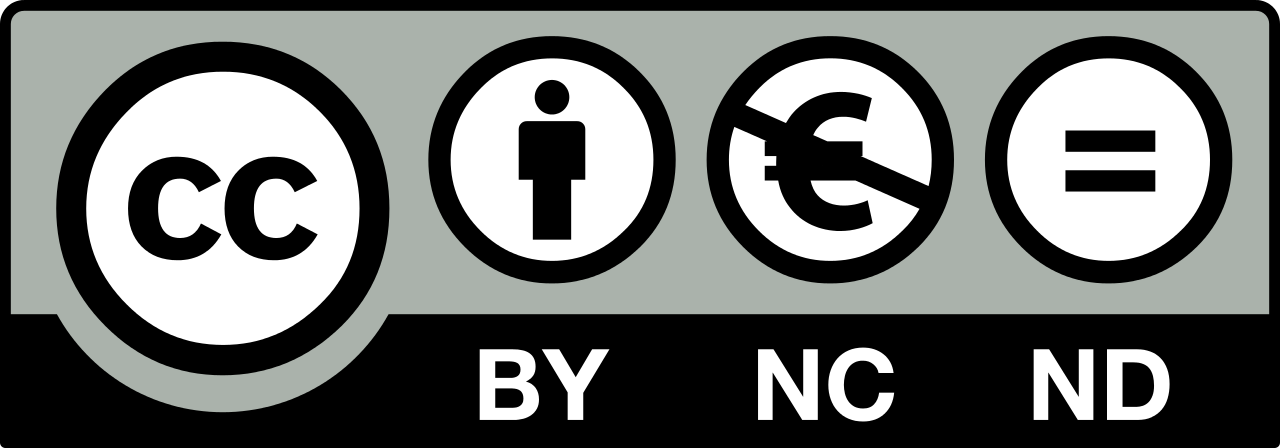Editoriali
Sulle migrazioni serve una strategia europea che guardi al medio termine
Tre milioni di rifugiati in più nel 2020, con la crisi climatica che contribuisce agli sfollamenti. L’Europa cerca una soluzione che però non può riguardare soltanto il rimpallo di qualche decina di migliaia di disperati. [VIDEO]
di Donato Speroni
Fino a quando si potrà continuare a tacere? Fino a quando a fingere di non sapere chi e che cosa viene pagato per la tranquillità falsa e senza coscienza d'Europa?
La domanda posta da Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, arriva in una settimana nella quale si torna a dedicare attenzione al problema delle migrazioni. Domenica 20 si è celebrata la giornata mondiale del rifugiato. Spesso guardiamo alle numerosissime celebrazioni dell’Onu come a eventi pieni di inutile retorica; tuttavia queste giornate sono anche un’occasione per riflettere su dati inediti e così è avvenuto per il World refugee day, che ha fornito all’Unhcr, l’alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, l’occasione per diffondere il suo rapporto “Global trends in forced displacement - 2020”.
Da questo documento abbiamo appreso che nel mondo ci sono 82,4 milioni di persone che alla fine dello scorso anno avevano dovuto abbandonare le loro case “come risultato di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani o altri eventi che hanno seriamente minacciato l’ordine pubblico”. Notiamo che in quest’ultima categoria sono compresi anche i disastri naturali che hanno costretto intere popolazioni a lasciare le loro terre. Il dato comprende 26,4 milioni di rifugiati sotto mandato dell’Onu, compresi 5,7 milioni di palestinesi. Tra gli altri 48 milioni di persone che sono rimaste all’interno del loro Paese (internally displaced people), 4,1 milioni di richiedenti asilo e 3,9 milioni di venezuelani fuggiti all’estero.
Il numero delle persone in forced displacement è in costante crescita: a fine 2019 erano 79,5 milioni, quindi nel 2020 nonostante la pandemia sono aumentate di quasi tre milioni.
Due dati saltano subito all’occhio. Il primo è che più di due terzi, per la precisione il 68% dei rifugiati sotto gestione Unhcr, proviene da cinque Paesi: Siria, Venezuela, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. Il secondo è che l’86% di chi è costretto a lasciare la propria casa si ferma nel proprio o in un altro Paese in via di sviluppo. Sono dunque una minoranza quelli che raggiungono l’Europa o altri Paesi ricchi, in parte per la difficoltà di entrarvi, ma anche perché molti desiderano rimanere per quanto possibile vicino a casa, nella speranza di farvi ritorno.
ASCOLTA ANCHE L'ULTIMA PUNTATA DI ALTA SOSTENIBILITA': 'MIGRAZIONI TRA CRISI CLIMATICA, DISUGUAGLIANZE DI GENERE E PRNN'
La giornata del rifugiato non è stato però l’unico spunto per parlare di questo argomento. In preparazione della riunione del Consiglio d’Europa che si è aperto giovedì 24, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha fatto un nuovo tentativo per arrivare a una politica comune di ridistribuzione dei migranti che sbarcano sulle coste nord del Mediterraneo e soprattutto da noi. È un argomento sul quale non è facile trovare un accordo e che si scompone in diversi sotto temi.
I corridoi umanitari. La soluzione ottimale è individuare gli aventi diritto allo status di rifugiato fin dal Paese di origine e comunque da un Paese di transizione, per portarli in Europa senza far correre loro pericoli. Funziona così, per esempio, il progetto-pilota, realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle chiese evangeliche in Italia, la Tavola valdese e la Cei-Caritas. Purtroppo parliamo di numeri ridotti: sul sito di Sant’Egidio si legge che dal 2016 a oggi questa operazione ha interessato 3.500 persone.
Le ridistribuzioni e i “dublinanti”. È ormai chiaro che non tutti i 27 Paesi dell’Ue accetteranno il carico dei ricollocamenti. Sarà già un successo ottenere dai Paesi recalcitranti un contributo economico a favore di chi deve sopportare l’impatto delle migrazioni. Sulla Repubblica, Claudio Tito riferisce di una trattativa in corso da tempo tra Parigi, Berlino e Roma: Germania e Francia sarebbero disposti a ricevere un certo numero di migranti irregolari sbarcati in Italia, ma... al netto dei cosiddetti “dublinanti!” cioè di quegli immigrati che si sono registrati in Italia e hanno poi varcato i confini per stabilirsi (contrariamente a quanto prescrive l’Accordo di Dublino) in altri Paesi europei. Se ritornassero da noi, alla fine il vantaggio per l’Italia sarebbe piuttosto ridotto.
Fermarli nei Paesi esterni. La Ue è pronta a finanziare i campi di raccolta nei Paesi al di fuori dall’Unione, a cominciare dalla Turchia che già da anni riceve finanziamenti a questo scopo. Una cifra consistente potrebbe anche essere destinata alla Libia, ma il problema non è soltanto quello dei soldi. Numerose testimonianze pubblicate anche in questi giorni riferiscono delle condizioni vergognose, delle violenze e degli stupri che avvengono nei campi di raccolta libici. Su questo sappiamo e tacciamo ed è questa la situazione che ha indotto Marco Tarquinio a lanciare la sua invettiva contro l’Europa. Per quante riserve si possano avere sul regime turco e sul suo autoritario presidente Recep Tayyip Erdoğan, i campi di raccolta turchi sono diversi da quelli libici, come conferma sulla Stampa l’alto Commissario per i rifugiati Filippo Grandi:
Tra Turchia e Libia ci sono molte differenze. La gente viene rimpatriata in Turchia con dei rischi, ma lì, in generale, c’è un buon sistema di accoglienza e protezione. In Libia non c’è nulla di tutto ciò, e noi ne siamo fuori. Avere un accordo con Tripoli per limitare gli arrivi rafforzando la guardia costiera libica non è di per sé una cattiva soluzione, ma bisogna rinforzare tutte le istituzioni, soprattutto quelle che si occupano dei migranti. Recuperare le persone in mare per sbatterle in quei centri di detenzione con un trattamento disumano non è accettabile. Se ci fosse un accordo che garantisce il rispetto dei diritti sarebbe un’altra cosa.
Per ora tuttavia siamo ben lontani dall’avere ottenuto la garanzia di questi diritti e gli accordi in queste condizioni non sono accettabili.
Rimandarli indietro. È ormai chiaro che il rimpatrio dei migranti irregolare nei Paesi d’origine è una operazione molto complicata. Questi Paesi hanno tutto l’interesse non solo ad alleggerire la pressione demografica, ma anche ad avere loro cittadini in Europa, che quasi sempre riescono a rimandare alle famiglie delle rimesse che contribuiscono alla bilancia dei pagamenti. Diversa è l’ipotesi di spostare in massa i migranti non voluti verso un Paese, probabilmente africano, che sia disposto ad accoglierli, a fronte di un congruo pagamento. È la soluzione che è stata approvata dal parlamento danese. Si è parlato di possibili accordi con Egitto o Tunisia, ma gli sviluppi sono tutti da vedere. Un tentativo in questo senso è stato fatto anche da Israele, come ha raccontato il deputato della Knesset Mossi Raz nel corso di un panel che ho avuto il piacere di moderare a conclusione di un convegno sui migranti climatici organizzato dalla Università della Calabria. Alcune decine di migliaia di africani (non ebrei) sono riusciti ad arrivare nel Paese attraversando il deserto del Sinai, nonostante le bande di predoni che rapiscono e violentano alla stessa stregua dei carcerieri libici. Il governo di Gerusalemme li ha accolti senza dar loro né la cittadinanza né lo status di rifugiati, ma ha mandato una delegazione in Kenya e Ruanda per verificare se questi Paesi erano disposti a riceverli. Alla fine non se n’è fatto nulla, sia perché i governi africani non erano favorevoli, sia perché le condizioni umane non sarebbero state adeguate. Così gli africani restano in Israele in una situazione ambigua, ed è probabile che tutti i progetti di forzata delocalizzazione vadano a finire nello stesso modo.
Il rapporto dell’Unhcr mette anche in evidenza l’importanza della crisi climatica.
Il climate change favorisce gli esodi e aumenta la vulnerabilità di quelli che già sarebbero costretti a fuggire. Chi deve abbandonare la propria terra ed è senza un Paese è spesso in prima linea nell’emergenza climatica. Molti vivono in hotspot climatici dove solitamente non hanno le risorse per adattarsi a un clima sempre più inospitale. Le dinamiche della povertà, dell’insicurezza alimentare, dei cambiamenti climatici e degli sfollamenti sono sempre più interconnesse e si rinforzano costringendo sempre più persone a cercare sicurezza personale ed economica.
Siamo dunque davanti a un fenomeno certamente destinato ad aggravarsi nei prossimi anni. Molti Paesi in via di sviluppo risentiranno pesantemente della crisi climatica. C’è da augurarsi che il prossimo vertice di Glasgow acceleri efficacemente le politiche di mitigazione, ma si dovrà affrontare comunque un problema di adattamento a mutate condizioni climatiche per centinaia di milioni di persone. È impossibile avere ricette sicure di fronte alla dimensione di questo problema, ma dall’incontro sui migranti climatici che prima ho citato, ho ricavato tre convinzioni.
- Il migrante climatico è in una situazione diversa dal migrante economico, perché non può essere rimandato a un luogo d’origine divenuto inospitale, ma dalle testimonianze degli esperti ho capito che è inutile illudersi che questo status venga presto riconosciuto dalle organizzazioni internazionali. Ogni Paese, o ogni gruppo di Paesi come l’Unione europea, deve trovare il proprio modo di affrontare il problema. Ma non lo può ignorare.
- È necessario mobilitare risorse pubbliche e private e individuare nei Paesi minacciati dalla crisi climatica quali sono le organizzazioni più efficaci con cui collaborare. In troppi casi gli aiuti “ufficiali” sono stati dispersi.
- La tecnologia può fare molto. Anche dove si vive una situazione di carenza idrica, come per esempio sule rive del lago Ciad, le moderne tecniche di irrigazione consentono di sfruttare al meglio la poca acqua disponibile.
In conclusione, il problema delle migrazioni e dei rifugiati è ben più ampio di quello al quale siamo abituati a guardare, di ricollocare dall’uno all’altro Paese europeo qualche decina di migliaia di disperati. Senza dubbio l’Italia non lo può affrontare da sola, ma l’autorevolezza che ha acquisito con questo governo deve essere impiegata anche per costringere tutta l’Unione a ragionare su una sfida di medio e lungo termine che potrebbe sconvolgere gli equilibri geopolitici.
Non posso concludere questa cronaca della settimana senza menzionare alcuni eventi significativi che riguardano l’ASviS. Il 17 giugno, il webinar “Parità di genere e sviluppo sostenibile” ha affrontato il tema degli interventi necessari per favorire l’occupazione femminile e alleggerire il lavoro di cura.
Il 21, il presidente e portavoce dell’Alleanza, Pierluigi Stefanini, ha riferito alle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera sulle valutazioni dell’ASviS in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ribadendo anche l’importanza di inserire il concetto di sviluppo sostenibile in Costituzione.
La campagna “AlleanzaAgisce”, l’iniziativa dell’ASviS pensata per raccogliere, diffondere e garantire l'accesso immediato alle centinaia di progetti realizzati dai membri della rete dell’Alleanza in tutta Italia nei mesi più duri della pandemia, è stata riconosciuta tra le buone pratiche dall’Onu e citata tra le storie di successo relative agli SDGs. Corsi di formazione, assistenza psicologica a distanza e lezioni aperte a tutti sono state solo alcune delle iniziative organizzate.
Il 22 si è tenuto l’evento di presentazione del Quaderno ASviS sull’enciclica “Fratelli tutti” e il Goal 16. Per molti di noi, è stata la prima occasione dopo molti mesi per ritrovarsi “in presenza”. In tutto questo tempo abbiamo tenuto botta lavorando in smart working, ma rivedersi è stata una grande gioia e un segno di speranza.
GUARDA ANCHE: ASVISLIVE 'FRATELLI TUTTI E GOAL 16, UN PERCORSO COMUNE DI ISTITUZIONI E CITTADINI PER L'AGENDA 2030'