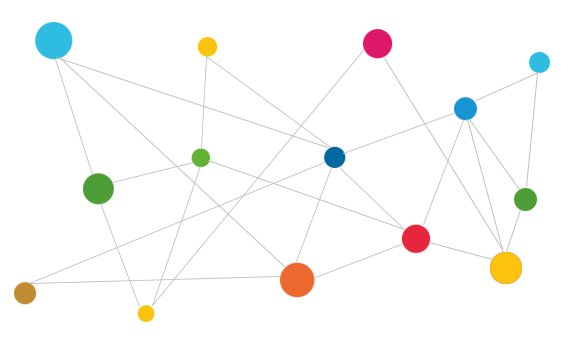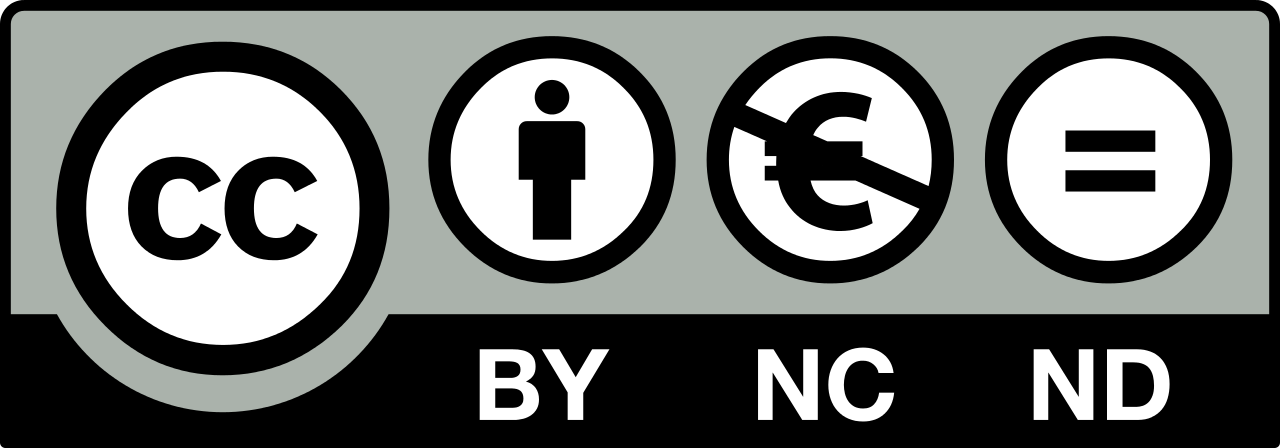Editoriali
Il ruolo della finanza e delle imprese nella lotta alla crisi climatica
Mentre si attende l’esito del confronto tra gli Stati, è in aumento l’impatto degli investimenti “verdi” e l’attenzione delle imprese ai criteri ambientali e sociali. Le iniziative europee contro il “greenwashing”.
di Donato Speroni
Nei prossimi giorni, dall’esito del vertice del G20 a Roma e della Cop 26 di Glasgow, sapremo fino a che punto i più importanti Paesi del mondo saranno disposti ad agire per mantenere l’impegno preso a Parigi nel 2015 di contenere l’aumento della temperatura media mondiale entro 1,5 gradi centigradi e comunque non oltre i 2 gradi rispetto all’epoca preindustriale.
Intanto però possiamo registrare la crescita della sensibilità del mondo della finanza e delle imprese: la sostenibilità sta assumendo un ruolo crescente nelle strategie aziendali, sia per ragioni di mera sopravvivenza (nessuno può prosperare in un mondo insostenibile), sia perché i consumatori sono sempre più attenti a questi aspetti e una buona immagine contribuisce al successo.
Ovviamente c’è un forte rischio di greenwashing, come tutti possiamo notare, essendo quotidianamente bombardati da pubblicità che ci annunciano prodotti e comportamenti “sostenibili”. Tuttavia si stanno mettendo a punto normative, soprattutto a livello europeo, che dovrebbero consentire di distinguere meglio i comportamenti effettivamente sostenibili da quelli solo “verniciati di verde”.
A questi temi l’ASviS in questi giorni ha dedicato molta attenzione: con un focus pubblicato su Futuranetwork, una puntata di Alta sostenibilità, la trasmissione curata dall’Alleanza su Radio Radicale, con la partecipazione a CSR Med a Napoli e con un convegno che si tiene il 29 ottobre a Ecomondo a Rimini.
La necessità che la finanza guardi ai comportamenti sostenibili era già stata segnalata dall’allora governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney, il quale nel 2015 aveva avvertito che il mondo della finanza era esposto a tre tipi di rischio climatico: innanzitutto quello del danneggiamento di beni propri o di beni assicurati a causa dei fenomeni meteorologici estremi; in secondo luogo, il rischio di azioni legali nei confronti delle imprese responsabili delle emissioni climalteranti; infine, lo spostamento della profittabilità a vantaggio delle nuove iniziative “verdi” a danno di settori come quelli dei carburanti fossili dai quali era opportuno disinvestire. Da allora, Carney è diventato inviato speciale del Segretario generale dell’Onu António Guterres per le azioni e la finanza sul clima e in questi giorni ha lanciato in un tweet un messaggio di speranza:
La Cop 26 di Glasgow è tra pochi giorni. Sotto la presidenza inglese si sono fatti formidabili progressi. Per quanto riguarda i privati, il 90% delle nostre priorità sono state raggiunte o sono in corso di realizzazione.
C’è da augurarsi che abbia ragione. In ogni caso, il ruolo della finanza era stato sottolineato fin dall’accordo di Parigi, nella Cop 21 del 2015: tra gli obiettivi indicati c’era la necessità di “rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima”. Questo valeva sia per i fondi pubblici, a cominciare dal Green climate fund da 100 miliardi all’anno dal 2020 destinato ai Paesi in via di sviluppo, ma anche per i fondi privati. Da allora, l’attenzione alla “finanza verde” ha continuato a crescere, stimolata anche dalle banche centrali. Il Network for greening the financial system (Ngfs), un gruppo che comprende 74 banche centrali e autorità di regolamentazione – tutte le più grandi a eccezione della Federal reserve statunitense – ha messo in evidenza che il cambiamento climatico è una forte fonte di rischio finanziario, e dunque “le banche e le società che prestano o assicurano beni come edifici nella città lagunare di Venezia o raffinerie di petrolio potrebbero subire gravi perdite future”.
I gestori dunque si interrogano su disinvestimenti e nuovi investimenti. C’è però chi ammonisce che nel settore c’è ancora molta confusione. Lo segnala un articolo di Mauro Del Corno sul Fattoquotidiano.it: secondo le stime più inclusive i prodotti finanziari in qualche modo riconducibili ai criteri Esg (environmental, social, governance, ossia ambiente, sociale e organizzazione aziendale) valgono oggi 35mila miliardi di dollari e rappresentano quindi il 36% dei patrimoni gestiti a livello globale. Tuttavia, se si adotta una definizione più stringente, il dato precipita a 2mila miliardi di euro.
“Oggi c’è una forte ambiguità definitoria e regolatoria che riguarda tutti questi prodotti. Esistono diversi rating non finanziari spesso difficilmente confrontabili tra di loro perché le domande da cui partono sono diverse”, dice Alfonso Del Giudice, professore di Finanza e direttore del master in Finanza sostenibile dell’Università Cattolica di Milano.
Fin dal 2018, l’Unione europea ha cominciato a costruire un quadro di regole comuni, con l’obiettivo di classificare che cosa è effettivamente sostenibile. Si è cominciato così a definire una “tassonomia”, cioè dei criteri generali, con una raccolta di schede che descrivono quali sono gl’investimenti sostenibili sulla base di principi scientifici, ponendo come scopo il conseguimento degli obiettivi ambientali delle politiche europee. Al momento le prime schede della tassonomia adottate e che entreranno in vigore nel 2022, si concentrano su due tipi d’investimento, per la mitigazione e per l’adattamento ai cambianti climatici. Per dichiarare sostenibili questi investimenti è però anche necessario che sia dimostrato che gli stessi non producano effetti negativi su altri aspetti ambientali ben definiti, quali l’uso sostenibile e la protezione degli ecosistemi, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento.
L’accesso alla finanza verde è una delle ragioni che favoriscono la diffusione del “reporting non finanziario”: poter presentare un bilancio di sostenibilità è un punto di forza nei confronti dei mercati dei capitali. Questo tipo di informazione è obbligatoria in Italia solo per le imprese oltre i 500 dipendenti, ma è allo studio la sua estensione, eventualmente in forma semplificata. L’Osservatorio Deloitte ha esaminato un campione di 202 società italiane che nel 2019 hanno presentato la Dichiarazione non finanziaria, sottolineando “una crescente maturità a livello di reportistica”.
Un ulteriore impulso in questa direzione proverrà dalla prossima direttiva Ue sulla due diligence obbligatoria sugli impatti ambientali e i diritti umani di cui si è parlato al convegno dell’ASviS a Ecomondo: un atto, già promosso dal Parlamento europeo, che richiederà a tutte le imprese dell’Ue e non Ue che operano sul mercato europeo, di rendicontare sugli impatti ambientali e sugli impatti sui diritti umani dei loro prodotti e servizi , in conformità con i Guiding principles on business and human rights (Ungps) dell’Onu, per tutta la loro catena di valore e di rimediare gli impatti negativi. I risultati della due diligence dovranno essere resi pubblici, anche agli investitori, con responsabilità civili e penali in caso di inadempienza.
Un ulteriore stimolo a una completa rendicontazione degli impatti sociali dell’attività aziendale può provenire dal bilancio di genere, cioè da quel documento, autonomo o incorporato nel bilancio di sostenibilità, che descrive i comportamenti dell’impresa nei confronti del personale femminile, in termini di parità salariale, opportunità di carriera, iniziative di conciliazione casa – lavoro come asili nido o part time volontario. Finora il bilancio di genere in Italia era limitato a pochi casi sperimentali, ma si valuta se incorporarlo nelle azioni esecutive del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La parità di genere è infatti un obiettivo trasversale del Pnrr, che deve informare tutte le azioni delle missioni che verranno finanziate. È quindi possibile che l’esame su questo aspetto venga richiesto a tutte le imprese che concorrono al Piano.
Come si vede il quadro è ancora frammentario, tra iniziative effettivamente sostenibili e greenwashing, ma alcune linee di tendenza sono piuttosto marcate: la crescente attenzione del mondo della finanza agli impatti climatici; l’adesione delle imprese ai criteri di rendicontazione nei confronti degli stakeholder, dai dipendenti ai consumatori, dalle comunità locali all’ambiente; infine, la marcata volontà di fare chiarezza e di favorire una positiva evoluzione nei comportamenti aziendali, soprattutto da parte dell’Unione europea.