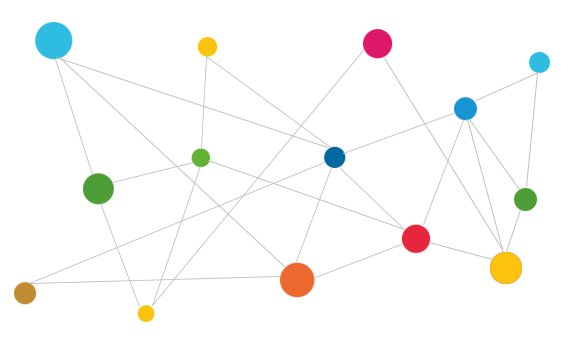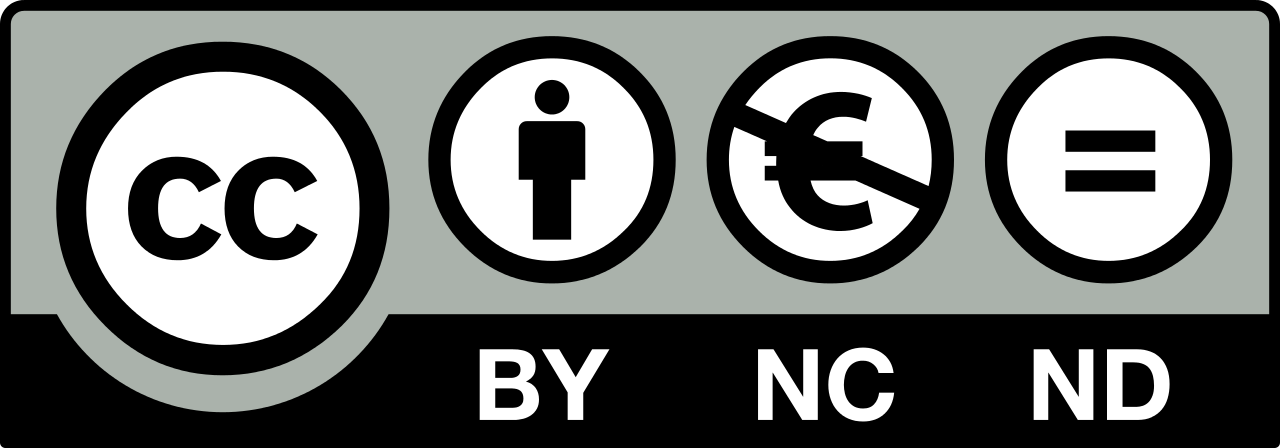Editoriali
Non possiamo lasciare ai giovani il compito di cogliere le mele più difficili
Per raggiungere la “neutralità climatica” si devono risolvere molti problemi aperti, dalla cattura del carbonio alla disponibilità di materiali rari. Occorre fin da adesso un grande investimento nella ricerca.
di Donato Speroni
Cingolani sul Corriere ha avvertito: «Non sarà bellissimo». Sviluppare entro nove anni tutta quell’energia dal solare per esempio significa tappezzare di pannelli oltre 200 mila ettari, quasi il 2% della superficie coltivata in Italia. Significa piantare pale eoliche letteralmente ovunque, compromettendo un paesaggio secolare e la risorsa del turismo. Eppure quel che colpisce è la distrazione. Fuori dalla cerchia degli specialisti, nel Paese non solo non se ne parla. Non c’è nessuna consapevolezza che queste scelte sono di fronte a noi.
Federico Fubini, sul Corriere della Sera, prende spunto dall’intervista del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani allo stesso giornale, per fare qualche calcolo. Per rispettare l’obiettivo europeo di abbattere le emissioni di gas serra del 55%, abbiamo bisogno di installare 7 gigawatt di produzione da fonti rinnovabili all’anno. Allo stato attuale delle tecnologie, abbiamo a disposizione solo il solare e l’eolico, ma se i calcoli che Fubini presenta sono giusti e si dovesse affidarsi soprattutto alla installazione di pannelli fotovoltaici, dovremmo ricoprire i tetti e i campi del Paese con una superficie di pannelli pari a oltre 30 metri quadri per italiano. Ma di questa sfida immane, che Cingolani giustamente segnala con toni preoccupati, non c’è adeguata coscienza.
Va detto che la tendenza a mettere i problemi sotto il tappeto non riguarda solo l’Italia. La Corte costituzionale tedesca ha bollato come insufficienti gli sforzi del governo di Berlino per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. In pratica, ragiona la Corte, anche abbattendo del 55% le emissioni entro il 2030, l’onere che viene scaricato sulle nuove generazioni è eccessivo e ingiusto. L’Economist ha spiegato così la sentenza:
La combinazione dei due impegni affida al futuro il maggior peso della decarbonizzazione: un onere ancora più pesante se si considera che le mele che pendono dai rami più bassi sono le più facili da cogliere.
Fuor di metafora, il problema è il seguente: la prima fase della riduzione delle emissioni non è semplice, come abbiamo visto, ma almeno sappiamo come fare. Ci sono però attività per le quali allo stato attuale delle tecnologie non siamo in grado di stabilire come arrivare a “emissioni zero”. Da questo punto di vista il concetto di “neutralità climatica” che l’Europa persegue è ambiguo.
L’obiettivo “emissioni zero” non impegna un Paese a raggiungere un livello specifico di emissioni, ma a sviluppare “emissioni negative” su una scala tale da pareggiare tutto quello che continuerà a emettere. Questo rende pressoché impossibile la quantificazione della riduzione di emissioni di gas serra tra il 2030 e il 2050, in certi casi 2060 (il riferimento è all’impegno cinese, Ndr) e quindi rende impossibile valutare il peso che viene posto a carico delle nuove generazioni.
Come si ottengono le “emissioni negative”? Il metodo che conosciamo meglio è l’estensione delle aree boschive perché gli alberi riassorbono CO2. Estendere i “polmoni verdi” dell’Europa è un processo lento e complesso, necessario ma insufficiente. Per il resto, tutto dipende da nuove tecnologie ancora agli inizi: le tecniche per sucking up carbon, riassorbire carbonio dall’atmosfera, o quelle per impedire che venga diffuso nell’aria, attraverso la carbon capture, con l’idea di stoccare l’anidride carbonica nel sottosuolo, magari nei giacimenti di fossili esauriti, sempre che questo non provochi movimenti sismici, come temono alcuni esperti.
Occorre dunque un grande investimento tecnologico, con risultati a medio e lungo termine e non si sta facendo abbastanza in questa direzione. Al meraviglioso sforzo globale delle imprese e dei governi che ha consentito la messa a punto in pochi mesi dei vaccini contro il Covid, non fa riscontro un analogo impegno di ricerca per combattere le emissioni di gas serra. Per le imprese si tratta di una ricerca di dubbia e differita redditività; per i governi di un impegno finanziario di cui la maggioranza dell’opinione pubblica non avverte ancora l’urgenza.
In ogni caso, serviranno scelte condivise molto difficili da raggiungere, anche perché costose. Commenta Stefano Agnoli, sempre sul Corriere:
A quanto e a che cosa, nel caso dell’emergenza climatica, siamo disposti a rinunciare? E quanto costa, se ha un prezzo, la giustizia ambientale tra generazioni? Negli Stati Uniti, ancora ai tempi di Obama, si era sviluppato il concetto del «costo sociale del carbonio». Un valore monetario del danno netto per la società conseguente all’emissione di una tonnellata di CO2 in un determinato anno. Un costo da far pagare a cittadini e sistema industriale che includa gli impatti del clima sulle future generazioni in termini di differente produttività agricola, effetti sulla salute, danni per disastri naturali, e persino conflitti e migrazioni ambientali. Certo, ci sono diversi modi per calcolarlo, diversi tassi di sconto da applicare, e l’amministrazione Trump era riuscita nell’impresa di ridurlo tra 1 e 7 dollari la tonnellata, quindi a renderlo inefficace, mentre secondo i calcoli del Climate Impact Lab dovrebbe essere più correttamente fissato a 125 dollari. Forse troppo, soprattutto in tempi di post-pandemia. Sono problemi complessi, è vero, e «mettere a terra», come si dice, i principi generali è sempre il compito più complicato. Ma sarebbe anche una bella sfida da proporre alla Cop 26 anglo-italiana di Glasgow il prossimo novembre.
Considerando che ogni italiano, per riscaldarsi o spostarsi, o attraverso i prodotti che consuma, provoca in media l’emissione di sette tonnellate di CO2 all’anno, si potrebbe calcolare un onere annuo di circa 700 euro pro capite, 42 miliardi che dovrebbero essere reimpiegati per affrontare tutti gli aspetti della crisi climatica, dalla ricerca agli interventi sociali per la “giusta transizione”, dalla promozione delle rinnovabili al risparmio energetico, sempre guardando all’impatto della crisi climatica sulle prossime generazioni.
Una cifra molto ingente. Va certamente in questa direzione la “seconda missione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che stanzia 59 miliardi (quasi 70 se si considerano i fondi collaterali) per alcuni di questi obiettivi. Ma dobbiamo avere ben chiara la dimensione complessiva dell’impegno che ci è richiesto in questo decennio, tenendo conto del fatto che dobbiamo sostenere anche la transizione ecologica dei Paesi in via di sviluppo, indispensabile per una mitigazione efficace della crisi climatica. Come segnalato sulla voce.info da Giulio Mario Cappelletti e Miriam Spalatro,
L’Ipcc dichiara necessaria una riduzione del 45 per cento delle emissioni globali di CO2 entro il 2030 rispetto al 2010 per raggiungere l’obiettivo di 1,5° C, nonché profonde riduzioni delle emissioni diverse dalla CO2.
In realtà, anche se Europa e Stati Uniti dichiarano obiettivi al 2030 più virtuosi, siamo ben lontani da questo impegno, se guardiamo la situazione in una prospettiva globale.
Ci sono anche altri segnali d’allarme che non vengono adeguatamente avvertiti. L’Agenzia internazionale dell’energia ha diffuso pochi giorni fa un rapporto speciale per segnalare il rischio di gravi carenze in alcuni “minerali critici” per lo sviluppo delle rinnovabili: rame, litio, nickel, cobalto, manganese e grafite, con una serie di raccomandazioni per diversificare le fonti e aumentare le capacità di riciclaggio di questi materiali.
Anche la gestione delle batterie delle auto elettriche pone problemi ancora irrisolti, come ricorda Luigi Bignami nella sua rubrica sul Domani:
Mentre le tradizionali batterie al piombo oggi sono ampiamente riciclate, lo stesso non si può dire per le versioni agli "ioni di litio" utilizzate nelle auto elettriche. Le batterie dei veicoli elettrici sono più grandi e più pesanti di quelle delle auto normali e sono composte da diverse centinaia di singole celle agli ioni di litio, che andrebbero tutte smontate singolarmente. Contengono materiali pericolosi e hanno una scomoda tendenza ad esplodere se smontate in modo errato. «Attualmente, a livello globale, è molto difficile ottenere dati precisi sulla percentuale di batterie agli ioni di litio che viene riciclata, ma il valore che va per la maggiore è di circa il 5 per cento», afferma Paul Anderson, co-direttore del Birmingham Centre for Strategic Elements and Critical Materials.
In conclusione, la sfida che l’umanità deve affrontare è enorme e per molti aspetti ancora oscura: non sappiamo abbastanza sulle tecniche di cattura del carbonio, non siamo sicuri di come e dove reperire i materiali che ci servono per le rinnovabili, anche le nuove batterie necessarie per immagazzinare l’energia pongono problemi tuttora irrisolti. Pochi giorni fa, più di cento premi Nobel e altri importanti esperti hanno lanciato un appello per una planetary stewardship, una “gestione planetaria che deve unire gli scienziati, i politici e l’opinione pubblica”.
Il documento riporta una frase significativa del premio Nobel per la chimica del 2020 Jennifer Doudna:
Dobbiamo abbattere le barriere che finora hanno diviso la scienza e il pubblico e che hanno favorito la diffusione senza controllo della sfiducia e dell’ignoranza. Se qualcosa impedirà all’umanità di superare le sfide del futuro saranno proprio queste barriere.
L’ appello si conclude così:
L’umanità si è accorta troppo tardi delle sfide e delle opportunità di una attiva stewardship planetaria, ma ci stiamo svegliando. L’adozione di decisioni di lungo termine basate sulla scienza è sempre in svantaggio rispetto alle esigenze del presente. I politici e gli scienziati devono lavorare insieme per superare la divisione fra l’evidenza esperta e le politiche di breve termine, al fine della sopravvivenza di tutte le forme di vita su questo pianeta nell’era dell’Antropocene. Il potenziale di lungo termine dell’umanità dipende dalla nostra capacità di oggi di valutare il nostro futuro comune. In ultima analisi significa valutare la resilienza delle società e la resilienza della biosfera della Terra.