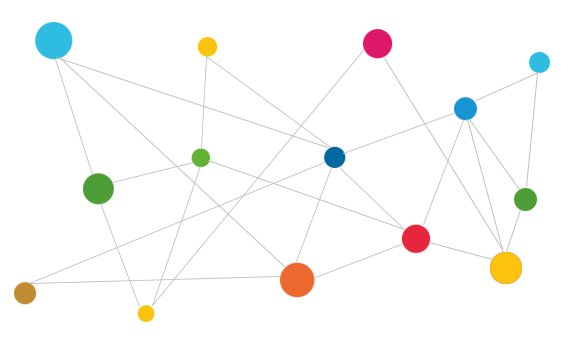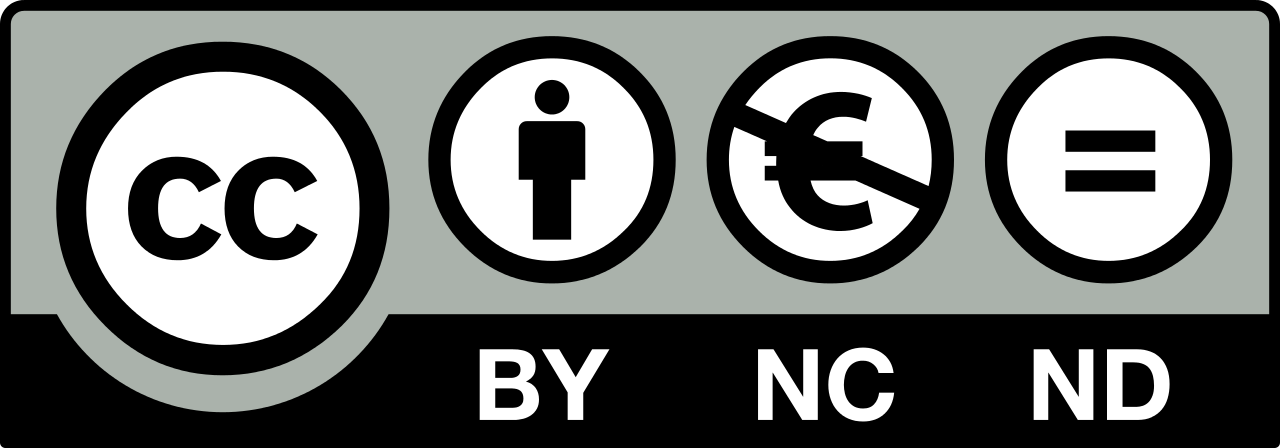Notizie dal mondo ASviS
La transizione climatica conviene, ma come sostenerla? L’evento ASviS-Ecco
Un fondo clima-energia simile al Next generation Eu dopo il 2026 e una riforma dell’architettura finanziaria tra le riflessioni sugli investimenti all’evento nel Festival. Gentiloni sulla transizione: non buttiamo via la leadership. 17/5/24
Potenziare gli investimenti nella transizione energetica aprirebbe un’opportunità irripetibile per accelerare l’innovazione a favore di un’ampia e sistemica trasformazione delle catene del valore globali. In questo modo si attiverebbero economie di scala rendendo accessibili a un’ampia maggioranza della popolazione i beni e i servizi a zero emissioni, con benefici sulla riduzione di disuguaglianze e povertà. Il percorso che porta alla neutralità climatica presenta però una serie di ostacoli. Se ne è discusso durante l’evento del Festival dello sviluppo sostenibile “Il futuro dell’Europa. Investire nella transizione climatica per tutti” di venerdì 10 maggio, che ha avuto luogo a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni.
L’iniziativa, organizzata dall’ASviS insieme a Ecco (think tank italiano per il clima), è stata aperta dalle parole del Commissario per l’economia europeo, Paolo Gentiloni, che ha ricordato gli impegni profusi per la transizione nel corso dell’ultima legislatura europea. “La Commissione europea, che sta per concludere il suo mandato, ha fatto dello sviluppo sostenibile la sua priorità, facendo progressi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, anche grazie alla spinta dell’ASviS. – ha dichiarato Gentiloni -. Stiamo lavorando molto con Eurostat per avere dati più affidabili sullo sviluppo sostenibile, che devono essere misurati per diventare centrali nell’agenda politica. Dalle recenti misurazioni viene fuori che nel 2023 rispetto al 2022 le emissioni sono calate del 15,5% e sono stati installati 56 Gigawatt di energia solare. Passi avanti sostenuti economicamente anche da risorse pubbliche. Il Next generation Eu ha per esempio messo in circolazione sostegni particolarmente concentrati sulla transizione ambientale e digitale. Naturalmente non basta, sappiamo che servono 620 miliardi di euro ogni anno da qui al 2030 per stare al passo con gli obiettivi che ci siamo prefissati”.
RIVEDI L'EVENTO
Gentiloni ha poi parlato dell’importanza dei capitali privati e del fatto che l’Europa ha “il Next generation Eu, gli investimenti privati e pubblici, e i programmi da attuare. Tutto questo esiste, ma dobbiamo comunque mettere in campo nuovi strumenti comuni europei altrimenti non possiamo paragonarci ai grandi player internazionali. Vogliamo mantenere la leadership nella transizione climatica rendendola socialmente giusta. Rinunciare alla leadership sarebbe un delitto. Non possiamo aspettare che siano gli altri a muoversi, questo si tradurrebbe anche in un errore per la nostra economia, perderemmo di competitività. Il costo implicito dell’inazione ci spinge ad andare avanti per evitare di ritrovarci con un’Europa più povera. Le difficoltà ci sono, sia chiaro, ma dobbiamo affrontarle e gestirle”.
In seguito è intervenuto Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, che ha ricordato che senza transizione in Italia calano Pil e occupazione, come è emerso il sette maggio dalla pubblicazione del rapporto “Scenari per l’Italia al 2030 e al 2050. Le scelte da compiere ora per uno sviluppo sostenibile”, e che “bisogna introdurre una carbon tax globale e considerare centrale il ruolo degli investimenti e dell’innovazione. Se aumentano le temperature fino a 5°C, da qui a fine secolo il Pil va a 0, perché semplicemente con quel livello di riscaldamento l’economia e la società, come oggi le conosciamo, scomparirebbero. Per evitare questo scenario abbiamo bisogno di una innovazione a tutto campo: nelle politiche, nelle regole, nel funzionamento dei mercati finanziari. La trasformazione avrebbe un impatto significativo anche nella riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil”.
Per Luca Bergamaschi, direttore e co-fondatore di Ecco “siamo in un momento topico, ciò che succede nel 2024 non resta nel 2024, basti pensare alle prossime elezioni europee e a quelle americane. Per questo motivo ci siamo chiesti se uno strumento simile al Next generation Eu possa essere messo in campo anche dopo il 2026, ogni cinque anni e fino al 2050. Stimiamo che un’esperienza del genere possa soddisfare il 20% degli investimenti pubblici necessari alla transizione, il tutto senza modificare i trattati dell’Unione. Va poi tenuto presente il contesto globale. Per esempio, l’Inflaction reduction act (Ira) americano punta a mobilitare per la transizione verde 330 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, la Cina ha già pianificato oltre 260 miliardi di dollari, il Regno unito dovrebbe accelerare e il Giappone ha messo in campo 140 miliardi di dollari. Il G7 e la Cina, dunque, si stanno muovendo in questa direzione, l’Europa sarà in grado di farlo? Può un fondo per il clima e l’energia, sul modello del Next generation Eu, funzionare per il post 2026? Cosa può offrire l’Europa al resto del mondo? Domande a cui possiamo rispondere solo aiutando i Paesi in difficoltà, che vogliono e aspirano a uno sviluppo sostenibile e cambiando impostazione alle banche multilaterali dello sviluppo, riformando le condizioni del debito che i Paesi poveri hanno contratto”.
Durante il primo panel di giornata, moderato da Davide Panzeri, responsabile programma europeo di Ecco think tank, sull’aumento degli investimenti green in Europa, Frank Elderson, membro del comitato esecutivo e vicepresidente del comitato di vigilanza della Bce, ha affermato che non è nella natura della Bce “formulare politiche per il clima. Ovviamente ne teniamo conto, ma noi siamo destinatari di queste politiche. In questo senso, le analisi dimostrano che le banche centrali beneficiano di una transizione seria e ordinata, soprattutto rispetto allo scenario del business as usual. Tuttavia, nonostante i passi avanti il flusso di finanziamenti continua a essere insufficiente. Un elemento che diventa ancor più preoccupante rispetto a quello che dice la scienza: la traiettoria che abbiamo intrapreso mostra che i governi non rispettano gli impegni. Questo perché i mercati dei capitali non stanno svolgendo il lavoro che serve, non soddisfano la domanda in asset verdi degli investitori”. Per quanto riguarda il Pnrr, “non è chiaro che impatto avrà”. C’è inoltre un capitolo importante, quello assicurativo: “solo il 25% di tutte le perdite catastrofali in Europa sono assicurate, e la mancanza di assicurazioni influenza l’economia e la stabilità finanziaria. Se le perdite non sono coperte le famiglie e le imprese hanno bisogno di più tempo per riprendersi, ciò rallenta l’attività economica, aumenta i rischi del sistema finanziario e impone l’intervento dei governi. La scienza climatica va presa seriamente. C’è tanto lavoro da fare, con urgenza, per le banche, per la loro resilienza”.
Gelsomina Vigliotti, vice presidente della Banca europea degli investimenti (Bei), ha evidenziato l’impegno dell’organizzazione sui finanziamenti legati al clima. “Negli anni ci siamo concentrati sempre di più sulla crisi climatica. Nel 2019 abbiamo deciso di non finanziare più i combustibili fossili con l’obiettivo di orientare il 50% dei nostri investimenti alla transizione entro il 2025. Entro il 2030 puntiamo invece a mobilitare mille miliardi di euro in attività legate al clima – ha detto Vigliotti -. Fino a ora siamo in linea con questi obiettivi, ma abbiamo notato che il mercato dei capitali finanzia poco la transizione su vasta scala. Anche per questo motivo ci siamo mossi, stiamo creando una iniziativa per generare grandi fondi europei, per fare in modo che le nuove realtà europee non siano assorbite dai fondi esteri, in particolare americani e asiatici”.
“Vedo che siamo tutti d’accordo su un punto, servono cifre enormi per la transizione – ha detto Marco Buti, titolare della cattedra ‘Tommaso Padoa-Schioppa’ all'Istituto universitario europeo -. Il ruolo di eventi come quello odierno è importante, l’ASviS ha presentato uno scenario disastroso sul futuro del Pil italiano. La mia esperienza con i politici insegna però che bisogna trasmettere anche un messaggio controfattuale, ma che dobbiamo insistere su questi temi è chiaro. Nel 2026 terminerà il Next generation Eu, sarebbe miope fare ciò che alcuni governi stanno tentando di fare, e cioè contare su una proroga di questo strumento. Perché può essere un alibi per prendersela con comodo adesso, io non spenderei il capitale politico per avere una proroga. Con le nuove regole fiscali dell’Unione tutto si giocherà sugli incentivi che però devono essere aggiustati e spalmati nel tempo”.
Il secondo panel, focalizzato sul ruolo dell’Europa negli investimenti della transizione globale, è stato invece moderato da Eleonora Cogo di Ecco. Ricordando che c’è chi trae vantaggi dalla transizione e chi invece deve sopportare i danni e i costi maggiori del riscaldamento globale, il consulente speciale per il presidente della banca inter-americana di sviluppo, Avinash Persaud, ha sottolineato che “il mondo ricco ha emesso grossa parte dei gas serra ma in posti dove vive il 40% della popolazione, come l’Africa, il tropico del capricorno e del cancro, che non hanno responsabilità nel riscaldamento globale, vediamo gli impatti maggiori. Per queste persone, secondo l’Ipcc, il costo della crisi climatica è quattro volte superiore rispetto ad altre parti del mondo. La trasformazione verde è fatta di tecnologie costose, e questo fa sì che grazie al settore privato buona parte della transizione avviene nei Paesi sviluppati. Dobbiamo ridurre quindi il costo del capitale per i Paesi in via di sviluppo”. La lotta al cambiamento climatico si concretizza nella mitigazione, nell’adattamento, nella resilienza, e nelle perdite e danni. “Parliamo di cose complementari ma diverse – ha aggiunto Persaud -. La prima genera ricavi, e qui torniamo al problema del costo del capitale. Per l’adattamento abbiamo bisogno delle banche. Per quanto riguarda perdite e danni, qui non ci sono né ricavi né risparmi: abbiamo bisogno di contributi e nuove imposte per generare quei 100 miliardi di dollari all’anno che servono al loss and damage. Per esempio, una imposta sul barile di petrolio potrebbe aiutare”.
Delle difficoltà per finanziare una transizione più giusta e cosa può fare l’Europa ne ha parlato John Asafu-Adjaye, centro africano per la trasformazione economica: “Il 57% della popolazione africana non ha elettricità e in pochi hanno l’acqua pulita. Per noi la transizione è anche una opportunità di sviluppo. Oggi la neutralità climatica è vista come occasione per creare posti di lavoro e combattere la povertà, ma le sfide sono tante. In media i Paesi africani hanno obiettivi molto ambiziosi sul clima, ma solo il 10%-15% degli investimenti è da fondi nazionali, il 75% proviene da prestiti e contributi internazionali. L’Africa riceve meno finanziamenti dell’Asia e dell’America. Bisogna accelerare le riforme per fare accedere i Paesi africani al circuito dei finanziamenti globali e servono maggiori trasferimenti di tecnologie verdi”.
“Tutti sono d’accordo che il sistema dell’architettura finanziaria non funziona, ma cosa facciamo per modificare la banca di sviluppo, gli istituti finanziari, il fondo monetario internazionale? – si è infine chiesta Rachel Kyte, professoressa di politica del clima alla Oxford university –. Ogni crisi ha le sue risposte. Attualmente vediamo che i flussi finanziari a causa dei tassi di interesse si dirigono più nei Paesi sviluppati. Enormi responsabilità in questi anni ricadono sulla frammentazione della finanza, e in questo i singoli membri dell’Unione europea hanno il compito di resistere alla tentazione di frammentare ulteriormente la situazione. Il G7 e l’Europa hanno il compito di collaborare in questa direzione. Il ministro delle finanze del Brasile ha lanciato la proposta di istituire delle imposte di carattere globale per finanziare il progresso nei Paesi in via di sviluppo, vediamo come reagirà il G7 su questo”.