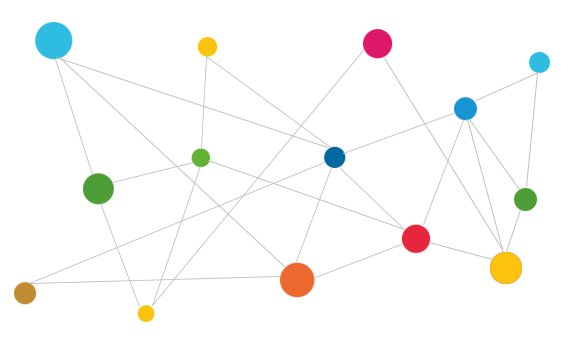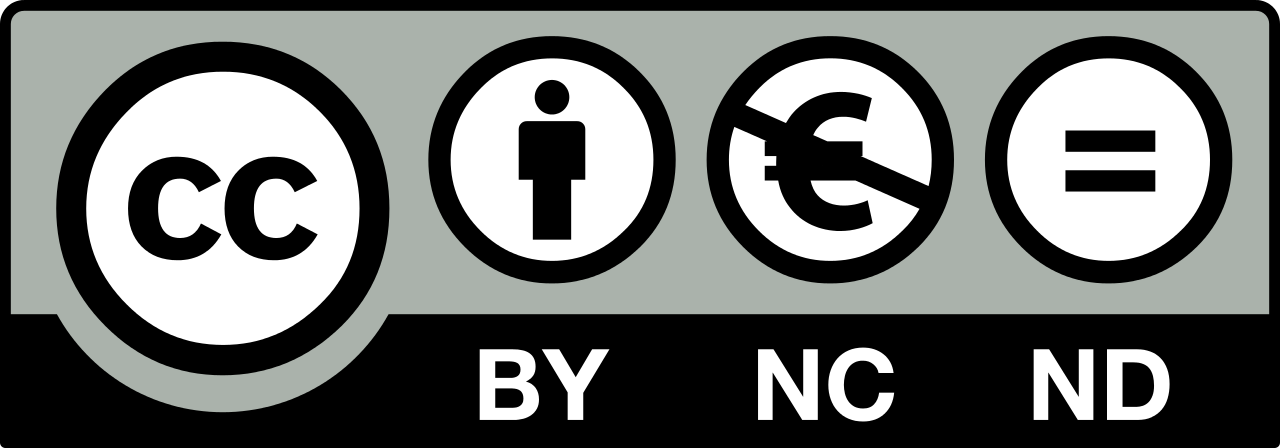Editoriali
In questa campagna elettorale è circolata una narrazione che vorrebbe ritardare la transizione ecologica per non danneggiare il sistema economico. È vero il contrario, ma farlo capire all’opinione pubblica sarà il grande impegno dei prossimi anni.
Quasi sessant’anni fa, quando ero capo ufficio stampa della Esso Standard Italiana (sì, nell’era dei fossili ho fatto anche questo e le grandi imprese operanti in Italia all’epoca davano fiducia a giovani poco più che ventenni), accompagnai un gruppo di giornalisti economici a visitare a uno strano impianto a Grenoble.
La Guerra dei sei giorni (1967) era finita da poco, Israele occupava ancora tutto il deserto del Sinai fino alla sponda del Canale di Suez. Per ritorsione, il governo egiziano aveva chiuso la via d’acqua, un blocco che sarebbe durato fino al 1975. Le compagnie petrolifere dovettero correre ai ripari e attrezzarsi con grandi navi in grado di abbattere i costi della circumnavigazione africana. Cominciò così l’epoca delle super petroliere, che oggi possono arrivare a trasportare oltre 500mila tonnellate di greggio e costituiscono terribili minacce per il futuro degli oceani. Negli anni ‘60 però, già un supertanker da 100mila tonnellate era considerato una nave enorme, difficili da maneggiare, anche in considerazione della ridotta elettronica di navigazione dell’epoca. Così, a Grenoble, in un laghetto attrezzato con segnali marini di vario genere, i futuri capitani di queste navi si calavano in barchette di un paio di metri che in proporzione avevano gli stessi limiti di manovrabilità di una superpetroliera, con tutte le difficoltà nel cambiare rotta, avvicinarsi a un molo ed evitare collisioni.
Questi ormoni alle prese con barchette impacciate mi sono tornati in mente ascoltando l’intervento di Giampiero Massolo al convegno conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Il presidente dell’Ispi, ex segretario generale della Farnesina ed ex responsabile dei nostri servizi segreti, con la sua grande esperienza geopolitica ha rovesciato l’impostazione abituale sulle strategie necessarie per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo tutti impegnati a raccomandare ai governi e alle Nazioni Unite quello che dovrebbero fare per garantire un futuro sostenibile, ma dobbiamo considerare le difficoltà di manovra di tutti i politici nel pilotare Paesi con forti resistenze al cambiamento. Che si parli di difesa o di immigrazione, di sacrifici per combattere la crisi climatica o di interventi fiscali per una maggiore giustizia sociale, nessun leader è in grado di guidare il proprio Paese in modo adeguato ai tempi, se è condizionato dalla zavorra di un’opinione pubblica poco informata e refrattaria a nuovi sacrifici. Soprattutto in democrazia.
La difficoltà di manovra a mio avviso è aumentata negli ultimi tempi per vari fattori: l’insoddisfazione di vasti ceti sociali comprese le classi medie dei Paesi più avanzati, la cattiva informazione diffusa da fonti non attendibili ma ascoltate (soprattutto nei social media), la polarizzazione delle opinioni e la perdita di abitudine al dialogo con chi ha idee diverse dalle nostre, e infine una certa presunzione legata a scarse conoscenze, che induce a credere di avere soluzioni semplici (e sbagliate) per problemi complessi che richiedono compromessi e consenso.
Dunque, se vogliamo mettere l’Europa e l’Italia su un percorso di sviluppo sostenibile, è necessario agire su due piani: un continuo dialogo con le forze politiche per stimolarle a fare scelte coerenti e concrete, ma anche un grande impegno di comunicazione nei confronti dell’opinione pubblica per correggere quelle narrazioni che comunque paralizzano le scelte dei governi.
Cominciamo dal primo punto. In queste settimane l’ASviS si è fortemente impegnata perché il confronto elettorale tenesse conto dei temi della sostenibilità. In apertura del Festival, nel suo “Rapporto di primavera” ha presentato anche un’analisi dei programmi elettorali delle forze in campo per il Parlamento europeo. Nell’evento conclusivo, forte delle iniziative e dei dibattiti di oltre 1.250 eventi sul territorio di cui una trentina organizzati direttamente dall’Alleanza, sono state presentate sette proposte per la nuova legislatura europea. Il contesto auspicato, come spiegato nella quinta proposta, è quello di “attuare riforme istituzionali verso una maggiore integrazione europea, rafforzare la democrazia e la partecipazione”.
Pur con molte resistenze, il quinquennio della Commissione von der Leyen ha visto un significativo ma temporaneo rafforzamento dei poteri dell’Unione per far fronte a sfide impreviste come la pandemia, con l’acquisto comune dei vaccini, la necessità di rilancio dell’economia grazie al Next generation Eu finanziato con debito europeo, la guerra in Ucraina con l’intensificarsi dei discorsi sulla necessità di una politica comune nel campo della difesa. Sul piano statutario, tuttavia, queste iniziative della Commissione erano giustificate da una situazione di emergenza, perché in condizioni normali i singoli Stati avrebbero dovuto provvedere autonomamente a queste esigenze. L’emergenza però è diventata normalità: si è visto che una Commissione forte è necessaria, non per imporre le regole sulle dimensioni delle vongole, come dicono i detrattori dell’Unione con qualche ragione sugli eccessi burocratici del passato, ma per far fronte a situazioni che gli Stati nazionali da soli saranno sempre meno in grado di affrontare.
Coltiviamo dunque la speranza che dalle urne domenica sera possa uscire un’Europa più forte e democratica, con istituzioni più efficaci. Ma l’altro grande lavoro che ci aspetta, l’impegno più difficile, comincia all’indomani delle elezioni perché è necessario aprire un dialogo con l’intera opinione pubblica e sfatare convinzioni purtroppo radicate.
In queste settimane abbiamo visto confrontarsi due tesi sulla transizione ecologica. Lasciamo da parte le boutade di chi dice che caldo e freddo si sono sempre alternati, così come la pioggia e la siccità: sciocchezze smentite ormai da migliaia di scienziati che da tempo ci avvertono dei rischi che corre la nostra civiltà per una crisi climatica senza precedenti da migliaia di anni. Il confronto “serio” è invece tra due tesi che riconoscono entrambe che è in corso un aumento delle temperature di origine antropica. La prima tesi, quella alla base dell’impegno dell’Alleanza, si può riassumere nel titolo dell’articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della sera tutto verde il 5 giugno, Giornata dell’ambiente: “La Terra non può attendere”. I ghiacciai si stanno sciogliendo, molti grandi laghi si stanno prosciugando, i mari si innalzano e milioni di persone devono lasciare le proprie terre: è evidente che l’umanità ha di fronte a sé un problema gravissimo, non solo ambientale ma sociale, da affrontare con priorità assoluta, cambiando il proprio modello produttivo, abituandosi a vedere le sfide in modo globale e solidale, ponendo le basi di una “giusta transizione” che tuteli anche le persone (si pensi alla grande industria dei fossili) che potrebbero essere svantaggiate dalle nuove scelte.
La seconda narrativa considera “ideologica” e “dogmatica” questa impostazione. Non nega la crisi climatica, ma sostiene che quanto si potrà fare deve tener conto di un vincolo: rispettare le esigenze dell’attuale assetto produttivo e delle forze di lavoro che vi sono impiegate. Insomma, “adelante Pedro con juicio, si puedes”, andiamo piano per non fare arrabbiare ulteriormente una folla (nel caso nostro una platea elettorale) già imbufalita. Una posizione legittima ma miope, che si basa su due assunti: il primo è che le politiche di mitigazione della crisi climatica saranno comunque inefficaci perché non si riuscirà a coinvolgere pienamente i Paesi emergenti e in via di sviluppo, che sono quelli nei quali crescerà maggiormente il fabbisogno di energia nei prossimi anni e che sono poco disposti a utilizzare fonti pulite più costose, considerando che i Paesi più ricchi sono responsabili di gran parte dei gas serra attualmente disciolti nell’atmosfera. Il secondo assunto si basa su una fideistica speranza nell’evoluzione tecnologica: oggi accelerare le soluzioni costerebbe sacrifici, meglio aspettare perché domani, con il mitico “nucleare di nuova generazione”, la cattura del carbonio sotto terra, magari interventi di geoingegneria per togliere la CO2 dell’atmosfera, i nostri problemi potrebbero essere risolti senza troppa fatica.
È facile confutare queste affermazioni. La necessità di una accelerata mitigazione climatica è avvertita in tutto il mondo, anche se giustamente i Paesi nuovi chiedono un indennizzo per i danni che stanno subendo e un aiuto per la transizione alle energie rinnovabili; le tecnologie “verdi” in buona parte già esistono ma non sono applicate adeguatamente se non cambiano gli indirizzi della politica e della finanza. Del resto, gli scenari elaborati dall’ASviS con Oxford Economics al 2030 e al 2050 mostrano la convenienza di una transizione accelerata.
In sostanza, la tesi dei “frenatori” si basa su una inversione della “variabile indipendente”: per loro, l’attuale sistema economico e sociale è l’elemento principale al quale si devono adeguare i tempi della transizione ecologica; per noi invece è il tempo della crisi ambientale, economica e sociale l’elemento determinante che deve imporre i necessari mutamenti del sistema economico. Per esempio, la narrazione “prudente” vorrebbe togliere il vincolo alle immatricolazioni di auto a motore endotermico in Europa dal 1935, per salvaguardare la filiera di produzione delle attuali vetture; chi invece difende gli impegni già assunti in Europa per la transizione ecologica fa presente che in oltre dieci anni, se lo si vuole, sarà certamente possibile attuare una politica industriale che riconverta le imprese e salvaguardi i lavoratori di questa filiera.
Dobbiamo ammettere, però, che la narrazione "prudente" ha fatto breccia nell'opinione pubblica minacciando anche di cancellare gli impegni europei già assunti con il Green deal. Ed è qui appunto che bisogna agire. Va aggiunto però che non si tratta di una battaglia contro i mulini a vento: a fronte di scetticismo, diffidenza e paura di esporsi da parte di molti leader politici, si è visto dal nostro Festival che milioni di persone avvertono non solo l’urgenza dei problemi, ma anche la necessità di impegnarsi.
Anche le imprese affrontano il futuro con strategie nuove. Già da qualche anno la sostenibilità è entrata con forza nei programmi proposti alle imprese dalle società di consulenza: criteri Esg (environment, social, governance), bilanci di sostenibilità, obblighi di reporting non finanziario hanno imposto alle aziende di acquisire competenze nuove. Da qualche tempo anche la parola “futuro” si sente più spesso nei consigli di amministrazione perché le aziende si preoccupano degli scenari in rapido cambiamento. Non è un caso che il pubblico dell’assemblea annuale dell’Afi (Associazione futuristi italiani) non era composto da stralunati maghi con il cappello a punta e la sfera di cristallo, ma da consulenti di strategic foresight. E lavorare sul futuro significa anche prendere in considerazione le scelte necessarie contro la crisi climatica e i suoi impatti sociali.
Molte forze, dunque, si stanno muovendo, ma l’opinione pubblica poco informata, timorosa, fuorviata da chi ne vuole strumentalizzare i timori, resta lo “zoccolo duro” sul quale è necessario intervenire, facendo capire che in palio non c’è la vita di lontani posteri, ma già l’immediato domani nostro e dei nostri figli.
Fonte copertina: varavin88, da 123rf.com