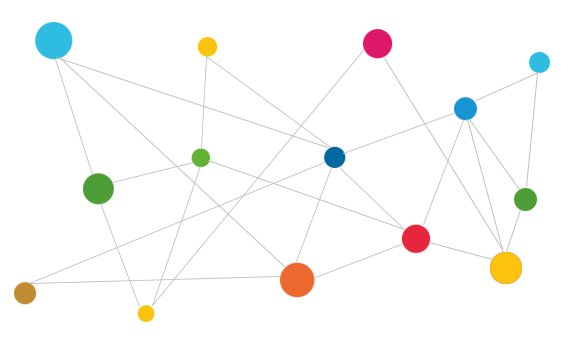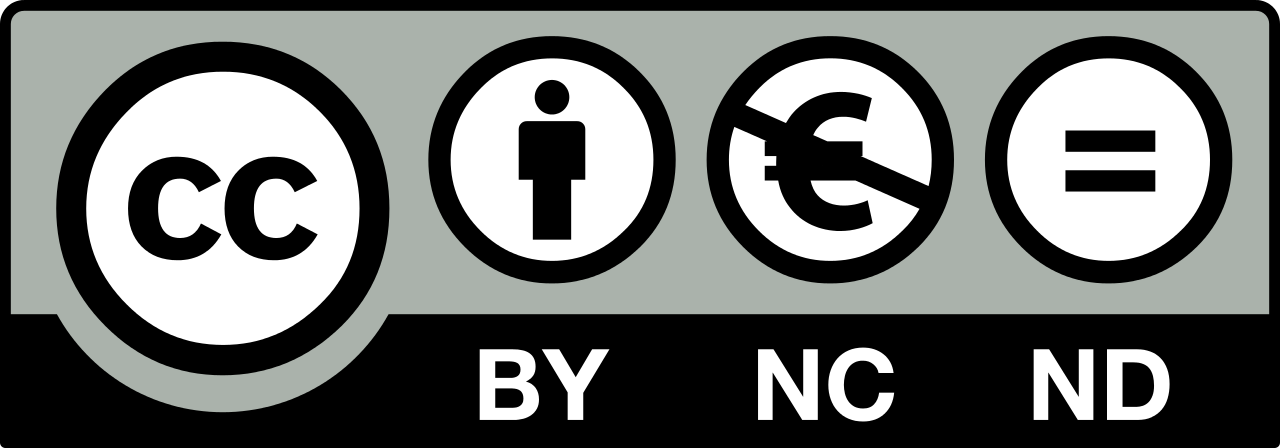Editoriali
Cop 27: senza il rapido taglio delle emissioni i danni da pagare saranno inestimabili
La creazione di un fondo per finanziare i danni subiti dai Paesi vulnerabili è un accordo storico, ma il summit egiziano complica il processo di riduzione dei gas serra e non mette in agenda la fine dell’era fossile.
di Ivan Manzo
È andata bene. Anzi, è andata male. Il bisogno impellente di buona parte del mondo dell’informazione di etichettare un processo negoziale così complesso, come lo sono le Conferenze dell’Onu, rischia di farci perdere pezzi importanti di una narrazione che deve accompagnare e indirizzare ogni attività umana – o meglio, antropica - verso la neutralità climatica.
Questa di Sharm el-Sheikh, luogo in cui si è tenuta la 27esima Conferenza delle parti (Cop 27) sul cambiamento climatico, doveva essere la “Cop dell’implementazione” - non a caso il documento finale si chiama “Sharm el-Sheikh Implementation Plan” -, partiamo col dire che purtroppo non lo è stata. Si registra infatti un sostanziale fallimento sul taglio delle emissioni climalteranti e sui piani di adattamento. La presidenza egiziana (in una Cop, in genere, luogo dell’avvenimento e presidenza coincidono) è stata brava a tenere alta l'attenzione sul “loss and damage” portando a casa un risultato storico e positivo. Allo stesso tempo, però, ha volutamente trascurato l’argomento mitigazione, strizzando così l’occhio ai propri interessi di profitto a breve termine - esportazioni di gas - e a quello, in generale, dei combustibili fossili.
Dalla decisione finale, slittata di circa 30 ore rispetto i tempi previsti per via di un accordo che nonostante le nottate fatte dai negoziatori non voleva arrivare, emerge qualche buona notizia e pesa enormemente la mancanza di ambizione.
Il maggior successo è senza dubbio l’istituzione di un fondo “loss and damage”. Se ne discute da tempo - addirittura dal summit di Rio 1992 -, ci pone di fronte alla questione del finanziamento delle perdite e dei danni subiti dai Paesi vulnerabili a causa della crisi climatica. Ricordiamo che questi Paesi sono quelli che hanno contribuito meno all’aumento della temperatura ma sono gli stessi che attualmente devono sopportare i maggiori disastri imposti dalla crisi climatica (si pensi alle isole del Pacifico che rischiano di scomparire, alle enormi inondazioni nel Pakistan, ai periodi di siccità che vivono le nazioni africane). A Cop 27 si è finalmente fatto un passo avanti sul fondo che opererà all’interno dell’Accordo di Parigi e dovrà essere avviato entro la prossima Cop 28 (Dubai). Un primo successo per i Paesi vulnerabili, resta ora da capire come sarà sviluppato e chi effettivamente si renderà disponibile a contribuire, insomma quali Paesi ci metteranno i soldi.
È opportuno fare qualche altra considerazione sull’argomento. L’istituzione del loss and damage rappresenta una prima vera ammissione di colpa da parte dei Paesi industrializzati in sede di negoziato. Non è poco. Motivo per cui, per decenni e fino alle ultime ore di questa Cop, Stati Uniti ed Europa, ma anche Paesi come Australia e Giappone, erano contrari a una richiesta che arrivava soprattutto dal gruppo negoziale “G77 + Cina”, che può contare su 134 Paesi tra cui parecchi, appunto, vulnerabili. A sbloccare il negoziato è stata la mossa dell’Europa e del suo inviato per il clima, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, che aprendo a questa possibilità ha fatto intendere che anche la Cina, vista ancora come Paese in via di sviluppo all’interno dell’Unfccc (Convenzione delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici), deve iniziare a finanziare questo genere di attività dato che si appresta a essere il secondo emettitore storico per gas serra in atmosfera (al momento è dietro Stati Uniti ed Europa). Insomma, l’ambiguità di una Cina potenza economica ma Paese in via di sviluppo in sede negoziale deve essere risolta.
Nessuno si deve però sentire al riparo dal cambiamento climatico, soprattutto chi vive nell’area mediterranea, come ha ricordato Grammenos Mastrojeni, Segretario generale aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo (Upm), durante un suo intervento nell’ultima puntata di Alta sostenibilità su Radio radicale.
“Il Mediterraneo ha una storia particolare nella crisi climatica – ha dichiarato Mastrojeni -, eppure non esiste nei negoziati per una ragione strutturale, visto che l’area mediterranea è suddivisa in tre gruppi negoziali. Abbiamo voluto portare la nostra voce (durante gli eventi a margine della Cop 27) per far valere i nostri interessi. Parliamo di una zona che rappresenta un ‘hot spot’ del cambiamento climatico: siamo la seconda regione al mondo per riscaldamento e le acque del Mediterraneo sono quelle che si scaldano più velocemente di tutte. Due fattori che si associano a previsioni a corto termine piuttosto drammatiche. Per esempio, si corre il rischio di avere 250 milioni di persone in scarsità idrica entro una quindicina d’anni. Le acque del Mediterraneo sono poi anche quelle che si innalzano più velocemente di tutte, e questo è un problema. 20 centimetri in più entro quindici anni, che sembrano pochi, fanno invece paura. Il problema è che non si tratta solo di acqua del mare che copre le coste, ma si tratta di acqua salata che si insinua nelle terre costiere. Il 40% della produzione agricola si fa sulle coste. Abbiamo il delta del Po che già sta soffrendo, immaginiamo cosa significhi salinizzare il delta del Nilo: vuol dire andare a minare la sicurezza alimentare di un regione che ha 120 milioni di abitanti. Crediamo però di aver trovato anche il paradigma di soluzione.
La scienza ci dice che nessuno, neanche gli Stati più ricchi, ha da solo i mezzi per fronteggiare una crisi così vasta e rapida. Ce la facciamo solo se ci mettiamo assieme, e questo ha alcune implicazioni politiche. Bisogna partire dalla considerazione che il mare Mediterraneo è di ricchi e poveri, di chi può e chi non può. Questa non omogeneità crea destabilizzazione, e nella peggiore delle ipotesi conflitti. Abbiamo tante differenze, ma se iniziamo a vederle come risorse ce la possiamo fare. L’Unione europea dice di voler decarbonizzare entro il 2050, ma dove lo facciamo l’idrogeno verde se non nei deserti dove si riesce a catturare l’energia necessaria? D’altro canto, il settore solare del Sud non può solo contare sui mercati interni, non ci sarebbero sufficienti capitali. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro”.
Tocca ora vedere come proseguiranno i lavori dai risvolti anche tecnici: cosa si intende per perdite e danni? Siamo sicuri che quell’evento estremo è stato causato o potenziato dalla crisi climatica? Il dibattito sulla definizione resta aperto, ma avendo sforato le 415 parti per milione (ppm) di CO2 in atmosfera, superando così la soglia di sicurezza posta a 350 ppm dalla comunità scientifica, tutto è loss and damage. Ma questo è solo il parere di chi scrive. La speranza, invece, è che i Paesi ricchi vedendosi costretti a pagare i danni accelerino la riduzione delle emissioni. Anche perché già hanno enormi difficoltà nel trovare risorse per il Green climate fund da destinare alle attività di mitigazione e adattamento.
Neanche quest’anno, infatti, il mondo ricco riuscirà a mobilitare i 100 miliardi di dollari all’anno in finanza per il clima, promessi ormai dalla Cop del 2009 di Copenaghen. Non lo ha fatto durante la Cop 27 e non lo ha mai fatto: si è arrivati al massimo ai circa 83 miliardi di dollari di due anni fa. Un grosso ritardo, basti pensare che l’obiettivo dei 100 miliardi all’anno era posto entro il 2020. Una cifra, tra l’altro, lontana da quella necessaria: secondo i migliori studi scientifici e anche quelli delle istituzioni finanziarie servirebbe almeno dieci volte tanto, 1000 miliardi di dollari l’anno.
In generale, se non contiamo solo i finanziamenti che necessitano i Paesi in via di sviluppo, la decisione finale della Cop 27 ricorda che bisogna mobilitare una cifra di almeno 4mila miliardi di dollari l’anno in energie rinnovabili entro il 2030 per avere buone probabilità di centrare la neutralità climatica – si intende che le emissioni antropiche di gas serra dovranno essere totalmente assorbite dai nostri ecosistemi - posta al 2050.
L’argomento è collegato a un altro discusso in Egitto: riformare il sistema finanziario delle banche multilaterali di sviluppo che, allo stato attuale, sono inadeguate ad affrontare il riscaldamento globale. Per molti Paesi resta infatti difficile accedere al credito, dato che diversi sono indebitati e alcuni rischiano il default. La decisione finale della Cop avanza in tal senso una proposta di riforma – che comprende anche Banca mondiale e Fondo monetario internazionale -, in accordo con quanto stabilito nell’ultimo summit del G20. Obiettivo è fornire uno strumento alternativo a supporto dei Paesi poveri, schiacciati dal debito che hanno nel tempo maturato verso quelli ricchi. Nel testo, inoltre, si fa riferimento anche alle nuove linee guida dell’Onu per il contrasto al greenwashing, indirizzate principalmente al settore privato (qui per un articolo in cui è presente una sintesi). Nulla di concreto, invece, emerge sulla tutela della biodiversità e, sui diritti, si fa semplicemente riferimento al diritto a godere di un ambiente pulito (nella prima stesura del testo c’era un intero capitolo sui diritti umani messi in connessione alle politiche di genere, alle migrazioni e alla discriminazione). Bene, invece, l’aver riconosciuto l’importante ruolo dei giovani, introducendo la figura del primo delegato giovanile della presidenza della Cop.
Sempre nell’ambito della finanza, proseguono le discussioni e si inizia a mettere nero su bianco la creazione di un nuovo meccanismo di mercato globale volto a generare crediti - e lo scambio di questi ultimi - per ridurre e rimuovere le emissioni in atmosfera (andrà a sostituire il vecchio Clean development mechanism del Protocollo di Kyoto).
E passiamo ora alle note più dolenti del summit egiziano, facendo prima un passo indietro. Durante la scorsa Cop 26 di Glasgow (qui per vedere cosa è successo a Glasgow) si decise che i Paesi dovevano aggiornare i propri NDCs – sono gli impegni di riduzione delle emissioni climalteranti che gli Stati devono rivedere periodicamente al rialzo – entro la Cop 27. Questi NDCs dovevano fornire una traiettoria per stare all’interno dell’obiettivo 1,5°C, o almeno avvicinarsi. Il risultato è che solo 33 Paesi su quasi 200 hanno aggiornato i propri impegni di riduzione - l’Unione europea ha annunciato un taglio delle emissioni del 57% entro il 2030 e rispetto i livelli del 1990, +2% rispetto al pacchetto “Fit for 55”, posizione comunque non in linea con quanto chiesto dalla comunità scientifica (e dall’ASviS nel suo Rapporto) che chiede un meno 65% -.
In molti, dunque, non hanno rispettato un pezzo del “Patto di Glasgow”. Di sicuro ha pesato il mutato scenario internazionale. L’invasione russa in Ucraina ha rotto i già delicati equilibri energetici, inducendo il mondo industrializzato a mettersi alla ricerca di nuovi idrocarburi, rendendo così più arduo fare previsioni sulle emissioni. L’impressione è che, anche questa volta, si stia cadendo nell’errore di non considerare questa crisi come un’opportunità per cambiare il sistema energetico orientando gli sforzi sul settore rinnovabile.
“Il gas è stato il grande protagonista di questa Cop, con un numero sorprendentemente elevato di accordi firmati a margine del vertice – ha scritto Toni Federico, coordinatore del Gruppo di lavoro ‘Energia e Clima’ (Goal 7-13) dell’ASviS, nel suo “Cronache di Cop” -. Il documento finale della Cop 27 contiene un provvedimento per incentivare ‘l'energia a basse emissioni’. Ciò potrebbe significare molte cose, dai parchi eolici e solari ai reattori nucleari e alle centrali elettriche a carbone dotate di cattura e stoccaggio del carbonio. Poiché a pensar male... ci si azzecca, potrebbe anche valere per il gas, che ha emissioni inferiori rispetto al carbone”.
In effetti durante la Cop 27 ci sono state forti pressioni da parte del settore fossile, presente al summit in maniera massiccia, come raccontato dal Guardian: “Ci sono 636 lobbisti delle industrie del petrolio e del gas registrati per partecipare all'evento delle Nazioni unite a Sharm el-Sheikh, in Egitto. A Glasgow la cifra era di 503, che superava in numero la delegazione di ogni singolo Paese. Quest'anno l'unico Paese con una delegazione più numerosa sono gli Emirati arabi uniti (ospiteranno la Cop del prossimo anno) che conta 1070 delegati registrati, in aumento rispetto ai 176 dello scorso anno”.
Nella trappola del gas è caduto anche il nostro governo che, nelle riunioni extra-Cop, si è assicurato con i vertici egiziani nuove forniture del combustibile fossile più in voga del momento. In generale c’è da registrare, con rammarico, una scarsa partecipazione del nuovo esecutivo italiano – i negoziatori italiani erano ovviamente presenti, a mancare erano i membri del governo – al dibattito: l’assenza durante le battute finali del summit significa rinunciare a influenzare il discorso nel momento in cui si prendono le vere decisioni.
Fortuna che tra quelle decisioni resta vivo l’obiettivo di 1,5°C - inteso come aumento medio della temperatura rispetto ai livelli pre-industriali (1850-1900) -, che per qualche giorno era stato messo in discussione. L’obiettivo 1,5°C è fondamentale se non vogliamo trasformare la crisi in catastrofe climatica, ma non resta tanto tempo per agire visto che abbiamo ormai toccato gli 1,2°C.
Nel testo finale della Cop, inoltre, non viene fatto alcun riferimento al raggiungimento del picco delle emissioni di gas serra entro il 2025 come richiesto dall’Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) nel suo ultimo report (qui per la parte sulla mitigazione). Elemento grave, se contiamo che i lavori dell’Ipcc vengono commissionati proprio dalle Cop per capire fin dove possiamo spingerci.
Battute d’arresto vengono segnate anche per l’attività di adattamento (a Glasgow si decise di raddoppiare i fondi dedicati) e per la più importante misura che possiamo mettere in atto per il contrasto al riscaldamento globale, lo stop ai combustibili fossili. Su questo punto siamo fermi allo scorso anno: viene menzionata solo l’uscita graduale dal carbone e la graduale eliminazione dei sussidi ai fossili. Nonostante l’80% dell’energia nel mondo sia ancora prodotta da fonti fossili, nessuna menzione poi per gas e petrolio, e nessuna data limite per il carbone. Niente nemmeno su quando e come porre fine ai sussidi pubblici alle fossili, che secondo una analisi condotta dall’Iea (Agenzia Internazionale dell’Energia) e dall’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nel 2021 ammontavano a 697 miliardi di dollari, quasi il doppio del 2020. Una cifra enorme, che però non spiega in modo completo il sostegno al settore. Se andiamo ad analizzare i flussi finanziari nella loro totalità includendo i sussidi indiretti, come fatto dal Fondo monetario internazionale, allora la cifra lievita a 5900 miliardi di dollari annui (dato al 2020). Un volume di affari che di fatto blocca la transizione energetica ed ecologica e che giustifica la frase “andiamo verso l’inferno climatico con l’acceleratore premuto" pronunciata dal Segretario generale delle Nazioni unite, António Guterres.
La mancanza di ambizione è stata così commentata da Timmermans, mentre si rivolgeva ai delegati di tutti i Paesi del mondo nella plenaria di chiusura (qui il testo del discorso e qui il video):
“Gli amici sono amici solo se ti dicono anche cose che non vorresti sentire. Questo è il decennio decisivo. Ma quello che abbiamo fatto è un passo insufficiente per le persone e per il pianeta. Non porta abbastanza sforzi aggiuntivi da parte dei principali emettitori che devono aumentare e accelerare i loro tagli alle emissioni. Non porta un maggior grado di fiducia sul raggiungimento degli impegni presi con l'Accordo di Parigi e a Glasgow lo scorso anno. Non affronta il divario enorme tra la scienza del clima e le nostre politiche climatiche. [...] Abbiamo sentito questa settimana che più di 80 Paesi sostengono l’obiettivo 1,5°C. Purtroppo, non lo vediamo riflesso nel documento finale. Un programma di lavoro che non blocca il percorso ma certamente pone ostacoli inutili, e consente alle parti di nascondersi dietro alle proprie responsabilità. Ma non smetteremo di lottare per avere di più. E nulla ci impedisce di fare di più. Riterremo noi stessi e tutti qui responsabili ai sensi dell'Accordo di Parigi. Ieri sera i nostri colloqui si sono bloccati. Molte parti, troppe parti, non sono pronte a fare ulteriori progressi nella lotta alla crisi climatica. Ci sono stati troppi tentativi persino di annullare quanto concordato a Glasgow. Alcuni hanno paura della transizione. Del costo del cambiamento. Mettono in discussione il ‘come’, non il ‘perché’. Capisco queste preoccupazioni. Molti europei le condividono. Ma voglio chiedere a tutti voi, colleghi qui in sala, di trovare il coraggio per superare quella paura. E tendo la mia mano per aiutarvi. L'Unione europea ha collaborazioni solide e fruttuose con molti di voi. Abbiamo firmato alcuni nuovi accordi significativi in queste ultime due settimane. Quindi cogliamo l'opportunità dei prossimi 12 mesi per trovare il coraggio di fare di più. Perché sappiamo che il costo dell'inazione è molto più alto del costo dell'azione”.
Una posizione condivisibile. Non basta più, tutti devono fare di più. Il clima non aspetta.